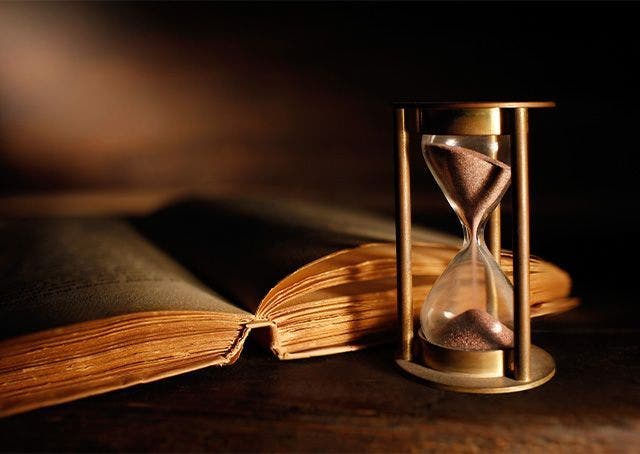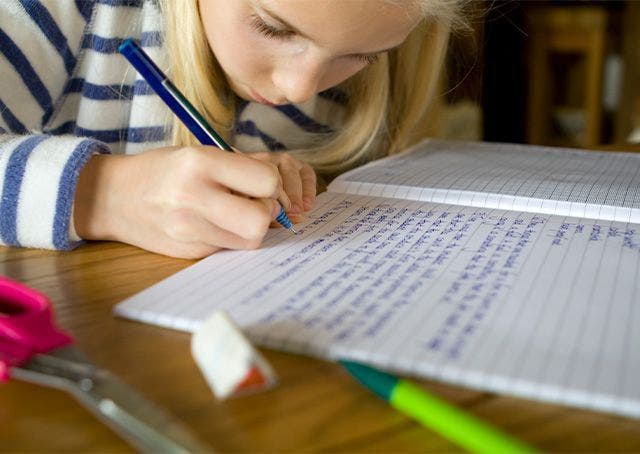Ho cinquemila battute (circa ottocento parole) per dire se concordo con le Nuove Indicazioni Nazionali. Il problema è che per la risposta me ne bastano due: no.
Ma siccome un commento bisogna pur farlo, cercherò di essere concreta. Andiamo per punti.
La linea del tempo, croce e delizia di ogni insegnante di storia
Come sa chiunque abbia mai tenuto una lezione o un laboratorio a tema storico, la difficoltà principale per chi vi ascolta (o vi legge) non è memorizzare nuove informazioni, ma collocarle su una linea del tempo. E no, non sto parlando solo dei bambini.
Cosa è successo prima? Cosa succederà dopo? Quanto tempo è passato da allora a oggi?
Senza una risposta a queste domande, “Paleolitico”, “Egizi”, “Giulio Cesare” sono solo parole. E, diciamolo, abbastanza inutili.
Infatti le Indicazioni Nazionali prevedono, tra gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, proprio la capacità di collocare gli eventi sulla linea del tempo. Benissimo.
Per rendergli le cose facili, lo facciamo cominciare a sei anni con l’Eneide (scritta in epoca romana), i poemi omerici (fissati in forma scritta nella Grecia arcaica e composti in età micenea), la Bibbia (la Bibbia? Nell’ora di storia?); al secondo anno, il Risorgimento; al terzo, salto indietro fino alla preistoria, per concludere con poche pagine random su Egizi, Sumeri, Babilonesi ecc. (del resto non vivevano in Italia, quindi perché sprecare tempo a studiarli?); in quarta e quinta, Greci, Romani e inizio del Medioevo.
Sinceramente: voi riuscireste a raccapezzarvi? Vedo già intere classi convinte che Garibaldi sia un uomo di Neanderthal…
Fonti sì, fonti no
Cito testualmente: “Anziché mirare all’obiettivo, del tutto irrealistico, di formare ragazzi (o perfino bambini!) capaci di leggere e interpretare le fonti, per poi valutarle criticamente magari alla luce delle diverse interpretazioni storiografiche, è consigliabile percorrere una via diversa”.
Peccato che quella che ho evidenziato in corsivo sia precisamente la definizione di “storia”.
Ma poi, di quali fonti stiamo parlando? Nessuno pretende che gli alunni si mettano a decifrare antichi testi in scrittura demotica! La storia è fatta soprattutto di oggetti. Pietra, ceramica, vetro, osso, corno, carbone: è questo che rimane, quando le civiltà scompaiono. È da qui (spesso e volentieri dalle antiche discariche!) che nasce la nostra interpretazione.
Troppo complesso per i bambini? Niente affatto. I bambini sono concreti, imparano mettendo le mani in pasta (e nei rifiuti, appunto). Non c’è modo migliore di fare storia con loro che partire dagli oggetti. Cosa ci dicono? E cosa ci raccontano di noi stessi?
Un esempio semplicissimo: le sepolture preistoriche, ricche di gioielli e armi, che per anni sono state interpretate come tombe di guerrieri. Le ultime analisi hanno rivelato che si tratta di sepolture femminili.
L’interpretazione cambia in base all’epoca in cui viviamo, agli strumenti che abbiamo a disposizione e al nostro punto di vista personale. Ogni storico deve assumersi la responsabilità della propria narrazione. È questo aspetto a rendere la storia una materia viva, un work in progress a cui tutti i cittadini possono dare il proprio contributo. Sì, perfino i bambini.
Che lo capiscono benissimo. Meglio degli adulti, direi.
La narrazione (che sofferenza)
Questo è il punto più doloroso, e tocca un nervo scoperto.
Anni passati a ripetere a destra e a manca che la storia è racconto, (hi)storytelling, non i fatti nudi e crudi ma l’interpretazione di quei fatti, e adesso mi tocca leggere che la narrazione è un metodo didattico alternativo allo studio delle fonti. Ecco, no.
Proprio perché la storia è narrazione, le fonti sono i pilastri alla base del racconto. L’abbiamo già detto: gli oggetti sono oggetti, le interpretazioni variano. Aspetto che, in teoria, viene sottolineato anche dalle Indicazioni Nazionali.
E allora perché ridurre la storia a un raccontino edificante somministrato dall’insegnante, che distingue i buoni e i cattivi (il giudizio morale!) così, a sentimento, senza possibilità di discussione? Come fa un bambino di sette anni a capire perché la piccola vedetta lombarda dev’essere “contenta d’aver dato la vita per la sua Lombardia”? O perché Elena di Troia non è una donna libera di innamorarsi di chi vuole, ma un premio che si aggiudica a suon di armi il maschio di turno?
Raccontare un aneddoto o un personaggio non contestualizzato (nel tempo, nello spazio, nella cultura di riferimento) non è fare storia. È indottrinamento.
E quindi: no, non riesco a trovare niente di buono in queste nuove indicazioni. Soprattutto perché, più che nuove, mi sembrano nate vecchie.
*Giorgia Cappelletti è archeologa, autrice e scrittrice