Accedi/registrati
Entra nel
Mondo Erickson
Mondo Erickson
Entra In Erickson
Informazione obbligatoria
Non sei ancora un utente registrato? Registrati ora.
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e da
Privacy Policy e
Terms of Service di Google
I mini gialli dei dettati 2
Carrello
Spedizioni veloci
Pagamenti sicuri
Totale:
Il tuo carrello è vuoto
|***
Libro
Quantità:
Filtra per categorie
Tematica
Argomento
Utile in caso di
Filtra
Risultati trovati: 17
Quattro consigli di Paolino Gianturco, dirigente scolastico e formatore dell’Associazione Italiana Dislessia (AID)
Con uno slancio e un entusiasmo che forse soltanto la scuola è in grado di esprimere, il mondo dell’istruzione si è lanciato a capofitto nella didattica a distanza, fin dai primi momenti della sospensione delle attività in presenza. Ciascuno ha intrapreso questa nuova avventura portandosi dietro, oltre a una encomiabile abnegazione, tutto il bagaglio di competenze acquisite negli anni, soprattutto nel campo delle tecnologie.
Ma adesso, a quasi due mesi di distanza, sembra arrivato il momento di riflettere - e moltissime scuole lo stanno facendo - sull’efficacia degli strumenti e delle metodologie applicate alla didattica, soprattutto se dall’altro lato dello schermo del pc si trova un alunno con bisogni educativi speciali.
Siamo sicuri che gli strumenti che stiamo utilizzando riescano davvero ad attuare quell’inclusione in grado di portare al successo formativo, che è l’obiettivo fondamentale del nostro sistema scolastico?
Per provare a dare una risposta a questo interrogativo, dobbiamo affrontare la questione sui due versanti che la caratterizzano: quello delle strategie più propriamente didattico – educative, e quello degli strumenti digitali impiegati nella didattica a distanza.
Perché strategie e strumenti possano combinarsi efficacemente, e quindi coinvolgere soprattutto chi ne ha più bisogno, sarà necessario agire in quattro direzioni principali.
Primo consiglio: lavorare sul piccolo gruppo
La prima leva a cui si può fare ricorso è il lavoro sul piccolo gruppo. In questo caso, la situazione di necessità - la didattica a distanza - potrebbe diventare virtù: se è vero, infatti, che sul piano organizzativo si sono dovuti riadattare tempi e durata delle lezioni ordinarie (più brevi di quelle in presenza e non di rado in fasce orarie anche pomeridiane), è anche vero che molti insegnanti trovano funzionale “incontrare”, o “reincontrare” i propri alunni in orari dedicati e magari per brevi periodi, per puntualizzare, in un piccolo gruppo, alcuni aspetti delle lezioni rivolte alla classe. Una modalità del genere non è sempre esperibile nella didattica ordinaria, dove la gestione del tempo-scuola, specialmente nella scuola secondaria, non facilita la creazione di piccoli gruppi o interventi didattici di recupero anche per frazioni di ora.
Nel piccolo gruppo trova maggiore spazio di ascolto chi potrebbe avere delle difficoltà a inserirsi nel gruppo anche quando si trova in classe con i compagni, in presenza; in una videoconferenza a distanza, inutile negarlo, emergono delle criticità che ognuno di noi ha imparato a conoscere bene in questo periodo: possono aversi rumori di fondo, problemi di attivazione dei video, distrazioni domestiche, e la mancanza del contatto visivo diretto del docente, a tenere viva l’attenzione, può essere un serio deficit per chi fa fatica a concentrarsi. L’ideale potrebbe essere affiancare dei brevi interventi didattici sul piccolo gruppo a quello sull’intero gruppo classe. Ciò è permesso sia dagli strumenti sincroni (la videoconferenza) che da quelli asincroni, (come i laboratori che si svolgono nelle classi virtuali), che rendono possibile una discussione partecipata, un coinvolgimento maggiore degli alunni che hanno necessità di essere inclusi e sono messi più agevolmente in grado di elaborare riflessioni metacognitive, strumento essenziale per l’accesso a ogni tipo di apprendimento.
Secondo consiglio: lavorare in compresenza (virtuale)
La seconda opportunità da cogliere è quella del lavoro in compresenza. Ogni docente sa che la possibilità di condividere insieme a un collega la lezione con il gruppo classe in orario curricolare è stata tolta alla scuola italiana da più di un decennio, e di questo ha sofferto soprattutto la scuola primaria, che per molti anni aveva saputo costruire delle importanti esperienze di didattica in team.
In questa fase, quasi paradossalmente, è proprio la difficoltà che stiamo affrontando a fornire una chance inaspettata alle scuole italiane, favorita dalle tecnologie digitali: un ritorno di fiamma per la scuola primaria, ma anche una scoperta che potrebbe rivelarsi interessante, per il suo carattere inedito, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.
La sperimentazione, sia pure a distanza, di esperienze di co-docenza, potrebbe far venire alla luce una modalità didattica dall’alto potenziale inclusivo: presentare un argomento (o meglio, un’attività laboratoriale) da diversi punti di vista e con approcci diversi, dà alla lezione un taglio meno settorializzato, trasversale, interdisciplinare come sarebbe giusto, anche senza il lavoro a distanza. L’alunno che ha maggiore bisogno di essere “catturato” nella relazione e nell’accesso all’apprendimento, attraverso un prisma costituito dalle diverse possibilità di risoluzione di un problema, i differenti punti di vista delle varie discipline, focalizza con maggiore efficacia il proprio apprendimento intorno a un macro-argomento, interpretando meglio le ragioni degli elementi strutturali che sta affrontando e trovando più facilmente le risposte alle proprie domande metacognitive.
Terzo consiglio: sfruttare gli strumenti di condivisione
La terza leva è quella della condivisione, resa possibile dall’utilizzo di strumenti di interazione tra alunni e insegnanti ma anche tra alunni e alunni. Interagire significa innanzitutto agire, e poi re-agire ai continui stimoli forniti dai propri interlocutori. Difficile nascondersi dietro allo schermo del pc - come in classe si tende a “scomparire” nelle ultime file - quando i docenti o i compagni chiedono non già di stare fermi ad ascoltare, ma di costruire cooperativamente l’oggetto dell’apprendimento.
La maggioranza degli strumenti digitali disponibili oggi per la didattica è orientata alla costruzione collaborativa: si organizzano presentazioni multimediali insieme ai compagni, si elaborano testi a quattro e più mani (come fossero sceneggiature cinematografiche), si completa una mappa concettuale iniziata dal docente, si disegna e si compone musica grazie agli strumenti di condivisione in cloud: le possibilità offerte dalla tecnologia spingono a potenziare al massimo la creazione condivisa dell’apprendimento. Questa relazione che attiva i meccanismi attentivi e cognitivi dell’alunno con BES può rivelarsi particolarmente efficace e trova nella didattica a distanza uno dei suoi luoghi di elezione, perché l’inclusione migliore non è calata dall’alto, ma condivisa nelle pratiche quotidiane, oltre che nei principi.
Quarto consiglio: utilizzare il rimando
Quarto e ultimo (ma non ultimo) strumento, che non può mancare da nessuna relazione didattica, e men che meno dalla didattica a distanza, è quello del ritorno, del feedback. Senza feedback non c’è didattica, ma soprattutto non c’è didattica a distanza. Solo se si garantisce una circolazione a doppio senso delle informazioni, e la si garantisce a ciclo continuo, il discente può apprendere (comprendendo i propri errori) e il docente può valutare. Si tratta di un elemento centrale, senza il quale il castello della didattica a distanza - che è un castello, bisogna ammetterlo, con le sue fragilità - rischia di crollare in poco tempo. D’altronde, se si osservano i docenti al lavoro in questi giorni, si vede un esercito di correttori infaticabili che si sforzano di assicurare la risposta ai propri alunni: perché sanno che in quella risposta sono riposte enormi aspettative da parte dei ragazzi, e non solo sotto il profilo valutativo, ma anche dal punto di vista emotivo-relazionale. Il compito corretto è pur sempre una forma di relazione, se vogliamo surrogata, che va a sostituire quella amata-odiata che si svolge nella vita di classe. Che sia il Registro Elettronico, o una delle tante piattaforme di interazione per lo svolgimento di test, magari sotto forma di gioco, o una classe virtuale, la risposta della scuola può arrivare all’alunno in maniera molto semplice e immediata. E allora, perché non farlo?
È anche in virtù del portato psicologico costituito dal feedback dell’insegnante, oltre naturalmente alla sua ricaduta pedagogica, che assicurare la risposta agli alunni significa contribuire ad assicurarne l’inclusione.
Leggi di più
Sabrina Franciosi, dirigente scolastico e formatrice AID, spiega a quali condizioni la Didattica a Distanza è efficace per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
Mai come in questo momento, una soluzione emergenziale come quella della didattica a distanza può rivelarsi un’opportunità per tutti gli alunni e, forse, soprattutto per coloro che vivono la relazione didattico-educativa incontrando delle difficoltà.
La prima condizione per la DAD: gli aspetti tecnici
Il punto di partenza, inutile nasconderlo, è di carattere tecnico. Per arrivare agli alunni con BES - e non solo - la didattica a distanza deve usare strumenti semplici e metodologie chiare. Questo significa, in primo luogo, che una scuola che rifletta sull’efficacia dei propri interventi dovrà sforzarsi di ridurre al minimo il numero di piattaforme o ausili digitali. La situazione attuale, è vero, ha colto di sorpresa una parte del mondo dell’istruzione, ma non è infrequente imbattersi in alunni grandi e piccoli che, nell’arco della stessa giornata, debbano destreggiarsi tra l’uso del registro elettronico, l’invio delle email, le classi virtuali (magari di piattaforme diverse a seconda del docente) e uno o più strumenti per la videolezione, essendo magari in grado di scansionare compiti e pagine del libro come se facessero la foto al proprio gatto.
Non tutte le scuole sono arrivate al momento dell’emergenza con una dotazione unitaria di strumenti per la didattica digitale, già collaudata, per così dire, “in tempo di pace”: e questo in alcuni casi, senza nulla togliere allo straordinario e generoso sforzo dei docenti, ha costretto molti ragazzi a fare i conti con un nuovo tipo di disorientamento, una sorta di sovraffollamento digitale, una specie di “cyber-Babele” davanti alla quale un alunno che ha le sue difficoltà di concentrazione, o che si perde nelle mille differenti procedure - procedure che la scuola, in onore al suo statuto, esige, non dimentichiamolo - può fare i conti con un nuovo ordine di difficoltà. Per questo motivo, anche se questo non è sempre facile da attuare a scuola, il primo consiglio è di unificare e ridurre gli strumenti digitali impiegati per la didattica.
Perché quello che stiamo scoprendo sempre di più, anche grazie a questo nuovo modo di fare scuole, è che i cosiddetti “nativi digitali” sono tutt’altro che padroni del mezzo, soprattutto quando sono chiamati a utilizzarlo in maniera attiva, creativa e costruttiva.
E qui veniamo al secondo punto: affinché gli strumenti digitali riescano a esprimere al meglio il loro potenziale didattico, devono essere semplici da usare; ma cosa significa “semplici”? Significa che tutti gli utenti - vale a dire alunni, docenti ma anche genitori, specialmente per gli alunni più piccoli - siano adeguatamente formati: e anche in questo caso, se non si è creduto, in passato, nella formazione di tutto il mondo della scuola (docenti alunni e famiglie) all’utilizzo dei nuovi strumenti digitali, che poi tanto nuovi non sono, a dire il vero, questa nuova relazione didattica mediata dal computer può certamente mettere gli alunni con bisogni educativi speciali di fronte a nuove difficoltà. Questa di sicuro è una grande occasione per colmare qualche lacuna in fatto di competenze digitali, e non a caso le opportunità di formazione si stanno moltiplicando, in queste settimane, sempre con una grandissima partecipazione del personale scolastico.
La seconda condizione per la DAD: il lavoro sul metodo e sull’organizzazione dello studio
Ma veniamo alla seconda condizione. Accanto alle problematiche di tipo tecnico legate all’uso degli strumenti digitali, e forse prima ancora di esse, si pone una questione centrale: che tipo di didattica potrà funzionare per gli alunni con BES, finché la scuola resterà a distanza?
Qui ci troviamo veramente davanti a una grande occasione per la nostra scuola: è giunto il momento di lavorare alla costruzione di una didattica leggera, che sia fondata sull’individuazione di contenuti essenziali e competenze di base.
Questo è il terreno - progettuale e metodologico - sul quale docenti e dirigenti sono chiamati ad esercitare tutte le proprie capacità per rivedere il curricolo e individuare gli elementi essenziali delle discipline.
Lo sforzo richiesto alle scuole, anche in questo caso, non è secondario, soprattutto per quegli istituti che in passato non hanno lavorato in questa direzione.
Fare una didattica a distanza che sia efficace per gli alunni con bisogni educativi speciali significa alleggerire molto il carico di compiti a casa, individuare i contenuti di base del curricolo, ma soprattutto fornire feedback: quando si assegna un compito, questo deve essere sempre corretto, perché l’alunno deve avere un ritorno per comprendere meglio quali siano le sue difficoltà, quali concetti ha interiorizzato e su quali apprendimenti invece non ha padronanza e quindi deve insistere.
Un altro nodo sensibile riguarda l’organizzazione del lavoro. I nostri alunni facilmente si disorientano, soprattutto i ragazzi con difficoltà sono sensibili e fragili, perdono i punti di riferimento e rischiano di non afferrare più il senso logico degli apprendimenti che vengono proposti. Avrebbero problemi di memorizzazione e di assimilazione a scuola, in presenza, figuriamoci a distanza e senza la possibilità di supervisione ravvicinata da parte del docente. Anche questa è una piega in cui rischia di annidarsi il germe della discriminazione socio-culturale: a nessuno sfugge che, in una relazione a distanza non sufficientemente gestita dalla scuola, una parte significativa del lavoro di organizzazione e gestione (dei materiali di studio come degli argomenti) possa finire per essere demandata alla collaborazione delle famiglie, non tutte dotate degli strumenti necessari per affiancare il proprio figlio.
Per questa ragione, in una fase come questa, una scuola sensibile al tema dei bisogni educativi speciali si sforzerà ancora di più di lavorare sul metodo e sull’organizzazione dello studio: come studiare una lezione, come sintetizzarla, come ricavarne una mappa concettuale, come recuperare le conoscenze pregresse e individuare i prerequisiti per i nuovi argomenti. Questi dovrebbero essere gli obiettivi prioritari della didattica a distanza, proprio tenendo come bussola di riferimento quegli alunni in difficoltà che a casa, senza l’apprendimento socializzato dell’aula scolastica, rischiano di fallire ulteriormente.
Le occasioni da cogliere con la DAD
Contenuti leggeri, dunque, e molto metodo di studio; a cui può aggiungersi un approccio trasversale tra le discipline e che affronti pochi temi: ma sui quali magari si propone quell’approfondimento che nella didattica ordinaria non sempre si ha il tempo di fare, e che invece potrebbe consentire, in questa situazione, una più incisiva fissazione dei contenuti.
SI tratta di linee di intervento, in parte richiamate anche dalle Note ministeriali di queste settimane, sulle quali è compito dei dirigenti orientare una riflessione il più possibile condivisa tra tutto il collegio dei docenti.
Ma soprattutto, siamo davanti a un’occasione da cogliere per costruire una scuola sempre più inclusiva.
Leggi di più
Alcune riflessioni e suggerimenti per attivare una didattica a distanza individualizzata
L’emergenza per il Coronavirus ha portato con sé una situazione della quale nessuno di noi aveva memoria e che ci ha colti fortemente impreparati: la chiusura delle scuole e la conseguente introduzione della didattica a distanza. Un sistema nuovo per tutti, insegnanti e alunni, i quali sono stati costretti a misurarsi in breve tempo con strumenti tecnologici prima quasi sconosciuti, ad apprendere il funzionamento di software e l’uso di risorse online, a far proprie procedure e, soprattutto, a relazionarsi attraverso lo schermo di un computer.
Come consulente per i disturbi dell’apprendimento e tutor DSA sto continuando a lavorare – anche io rigorosamente a distanza – con i miei clienti abituali, bambini e ragazzi con certificazione di disturbi dell’apprendimento: da loro ascolto ogni giorno le difficoltà e i problemi con i quali devono confrontarsi nella scuola di questo periodo. Vorrei quindi offrire qualche spunto di riflessione sull’applicazione della didattica a distanza agli studenti con disturbi dell’apprendimento, con particolare riferimento alle difficoltà che essa comporta.
L’uso delle piattaforme online
Spesso gli insegnanti pensano che gli alunni con DSA siano un po’ degli esperti informatici, dal momento che utilizzano quotidianamente il computer e i software compensativi per sopperire alle proprie difficoltà e per studiare in maniera efficace. Non è così, anzi molto sovente imparare a usare tanto il computer in sé quanto una serie di programmi per l’apprendimento rappresenta un primo scoglio non di poco conto, anche se poi sarà il loro aiuto più grande.
Il motivo è che la stragrande maggioranza dei ragazzi con disturbi dell’apprendimento fa molta fatica ad apprendere le procedure. Così come per loro è molto complesso ricordare procedure e funzioni nell’uso di un qualunque software, allo stesso modo è stato ed è ogni giorno molto faticoso apprendere, memorizzare e mettere in pratica le numerose sequenze da seguire nella didattica online.
La conseguenza è che molti di questi studenti spesso si confondono, si dimenticano, “si perdono”: consegnano i compiti via mail anziché su Classroom, non ritrovano le richieste degli insegnanti tra le tante comunicazioni pervenute nel tempo attraverso canali diversi, sbagliano a compilare i questionari di Google, non riescono a entrare nelle videolezioni su Meet.
Pensiamo ai ragazzi certificati e alle loro fragilità nell’orientarsi e nel memorizzare. Pensiamoli alle prese, contemporaneamente, con mail, registro elettronico, Classroom, Documenti Google, Meet; con insegnanti che si servono ora dell’uno ora dell’altro strumento per inviare compiti e materiale; con scadenze e appuntamenti online assai lontani da quelli molto concreti della loro quotidianità. Solo così possiamo capire quante frustrazioni e quanta fatica incontrino in questo periodo.
Le videolezioni e l’attenzione
È risaputo che i ragazzi con DSA, anche quando non vi sia una diagnosi di ADHD in comorbidità, presentano quasi sempre difficoltà a mantenere l’attenzione per un lungo periodo di tempo: la mente di questi alunni, infatti, si affatica molto più rapidamente di quella dei compagni, dal momento che l’impiego di risorse è notevolmente superiore. Il fatto che si distraggano facilmente, che talvolta vaghino altrove con la mente è quindi del tutto normale e, anzi, addirittura opportuno. A scuola è importante, con questi bambini e ragazzi, mantenere costante il contatto visivo, chiamarli per nome ogni volta che una mosca vola e loro la seguono con lo sguardo, porre loro qualche domanda ogni tanto, così da mantenerli attenti e presenti mentalmente oltre che fisicamente.
Ebbene, neppure gli insegnanti più bravi possono riuscirci in videolezione! Se uno studente si distrae durante la lezione su Meet, l’insegnante non se ne accorge; se la mosca vola e lui la segue, le parole del docente volano anch’esse, ma lontano, lontano… e sono perse! E non c’è contatto visivo, non c’è richiamo per nome, non c’è domanda che possa far tornare la loro mente presente, se non quando l’insegnante ne ponga una formale.
Il problema dell’attenzione diventa ancor più importante nel momento in cui gli alunni con DSA si trovano a casa propria. Questi ragazzi ottengono enormi vantaggi dall’ambiente scuola per il solo fatto di starci dentro: la presenza degli insegnanti, l’aiuto dei compagni, il continuo feedback offerto dal “circuito” spiegazione-domanda-chiarimento-rinforzo, la possibilità di uscire in gruppo ristretto con l’insegnante in compresenza lo aiutano a “stare sul pezzo” e sopperiscono, almeno in parte, alle sue difficoltà.
A casa tutto questo manca, inesorabilmente. Ai problemi di attenzione che il ragazzo ha di suo, quindi, si aggiungono l’impossibilità di ricevere l’aiuto offerto dal contesto scolastico e l’indubbia distraibilità causata dall’ambiente domestico. Porto esempi concreti tratti dalla mia esperienza lavorativa: so di studenti che seguono le videolezioni e contemporaneamente chattano su WhatsApp o giocano alla PlayStation, altri fanno merenda, altri sono in cucina mentre la mamma prepara il pranzo. E qui sorge un dilemma: è più opportuno che questi ragazzi stiano nella propria camera (o comunque in una parte della casa loro riservata), da soli ma a rischio distrazione, oppure in sala o in cucina, sotto l’occhio vigile dei genitori ma quasi certamente disturbati dalla presenza di questi? Dal mio punto di vista, la prima soluzione è la più opportuna, tuttavia i ragazzi vanno comunque vigilati, responsabilizzati, in modo che possano davvero concentrarsi sul lavoro scolastico, senza rumori e movimenti circostanti, ma anche senza giochi e cellulare!
I tempi ristretti
Una delle misure dispensative quasi sempre contenute nei piani didattici personalizzati degli studenti con disturbi dell’apprendimento è la concessione di tempi più lunghi per lo svolgimento dei compiti a casa e delle verifiche in classe. Questi sono imposti, innanzitutto, dalla maggiore lentezza che le difficoltà in lettura e scrittura comportano; in secondo luogo, dalla necessità di preparare strumenti compensativi quali schemi, riassunti e mappe concettuali e poi usarli in sede di verifica per recuperare il materiale studiato.
La DAD impone invece tempi ristretti: durante la videolezione, nello svolgimento dei compiti e, soprattutto, nella consegna degli stessi – Classroom è inesorabile: se non consegni, lo segnala, e la conseguenza normalmente è un «N.C.» sul registro elettronico –, nella compilazione di una verifica sui Moduli Google; nonché, come dicevo prima, nell’apprendimento di nuove istruzioni e procedure.
Invito i genitori a parlare con i docenti, a chiedere via mail tempi lunghi. Un altro esempio a questo proposito: la scorsa settimana una ragazzina che seguo avrebbe dovuto consegnare un elevato numero di esercizi di grammatica italiana; non ce la faceva, ha avuto bisogno del mio aiuto; e anche con il mio aiuto è stato necessario suddividere il compito in due parti. Così, ho proposto ai genitori di scrivere alla docente di italiano, spiegando che la prima parte del compito sarebbe stata consegnata nei tempi richiesti, la seconda qualche giorno più avanti. Così è stato, l’insegnante ha accolto la richiesta e la ragazzina ha terminato il compito con maggiore tranquillità.
Gli strumenti compensativi
Tutti gli strumenti compensativi, così come le misure dispensative, previsti dal PDP devono essere assolutamente garantiti anche in questo periodo. Dunque, in occasione di verifiche e interrogazioni online i ragazzi devono avere a disposizione gli schemi e le mappe che hanno preparato durante lo studio – e che devono aver inviato agli insegnanti con congruo anticipo, questo è un memo per gli studenti! –, la calcolatrice e quant’altro.
In particolare, gli insegnanti dovrebbero prestare molta attenzione al materiale che inviano, ricordando che i ragazzi con DSA devono poterlo usare con gli strumenti abituali. Ieri, ad esempio, lavoravo con un ragazzino che doveva svolgere un compito di inglese: la docente aveva inviato su Classroom una scheda in PDF su cui erano contenuti esercizi di completamento, ma il documento era protetto da password e perciò non modificabile. Il ragazzo, quindi, ha dovuto scrivere ex novo tutte le frasi in inglese su un documento di testo che ha poi inviato. Se la scheda in PDF non fosse stata protetta, invece, grazie al software PDF-XChange Editor l’alunno avrebbe potuto completare gli esercizi direttamente su di essa, con evidente risparmio di tempo e di fatica, dal momento che è disortografico.
Sempre ieri, sul computer di un’altra ragazzina non abbiamo potuto installare AnyDesk, grazie al quale io posso vedere lo schermo a distanza, perché il computer in questione è un Chromebook fornito dalla scuola, sul quale a livello amministrativo non è stata concessa la possibilità di installare alcun software, di fatto impedendo a me di lavorare con questa alunna in maniera proficua.
Oppure ancora, se l’insegnante invia un testo per una comprensione orale dovrebbe inviarlo in formato PDF, così che un ragazzo dislessico possa leggerlo tramite un software di sintesi vocale come LeggiXme; se, al contrario, invia una foto del testo sul libro, questa opportunità viene negata.
Le verifiche e la valutazione
Nella maggior parte dei casi gli studenti con DSA hanno diritto ad una diversa valutazione rispetto al resto della classe, che tenga conto delle difficoltà conseguenti ai disturbi certificati e non penalizzi ragazzi che non riuscirebbero a raggiungere i medesimi obiettivi dei compagni. Ciò si concretizza con la predisposizione da parte dei docenti di verifiche differenziate: non necessariamente semplificate, ma strutturate in maniera adeguata ai disturbi di ciascuno.
Con la didattica a distanza la maggior parte delle verifiche viene svolta sui questionari di Google ed è generalmente uguale per tutta la classe. È un sistema chiuso: se rispondi correttamente ti viene assegnato un punto, se sbagli o non rispondi zero punti. È quindi auspicabile che gli insegnanti, come hanno sempre fatto in tempi normali, predispongano questionari differenziati per gli alunni certificati, cosa peraltro resa più semplice dalla possibilità offerta da Google di duplicare un questionario esistente e poi modificarlo.
In conclusione, ritengo importante sottolineare la necessità di una didattica a distanza individualizzata, proprio come deve essere quella tradizionale quando viene applicata a bambini e ragazzi con disturbi dell’apprendimento.
In caso contrario, una situazione che già comporta un faticoso adattamento per tutti gli studenti rischia di trasformarsi in uno scoglio insormontabile per chi ha molte più difficoltà, con conseguente sconforto e abbassamento dell’autostima. O, ancor peggio, con la perdita di voglia di studiare perché «tanto saremo tutti promossi», senza pensare che poi, il prossimo anno, sarà tutto in salita.
Andrea Mangone, PhD, è Dottore di ricerca in psicologia dello sviluppo e dell’educazione, consulente per le difficoltà nello studio e i disturbi dell’apprendimento, tutor DSA e collaboratore della Sezione di Aosta dell’AID (Associazione Italiana Dislessia)
Leggi di più
Lo sai che… ci sono molte strategie per valorizzare le tue potenzialità e i tuoi punti di forza
1) Sei intelligente
Se hai un certificato di DSA puoi essere certo di una cosa: sei intelligente. Infatti una diagnosi di DSA non può essere fatta a meno che non ci sia un quoziente intellettivo nella norma o superiore alla norma. Quindi, se mai ti è venuto in mente qualche pensiero brutto, come ad esempio di essere stupido, sappi che non è così. I DSA sono una tua caratteristica, per tanto non sono né giusti né sbagliati, fanno parte di ciò che tu sei e imparare a conoscerli può aiutarti a conoscerti meglio. Puoi avere delle difficoltà, devi trovare altre strade rispetto a quelle canoniche, ma queste strade esistono e faranno parte del tuo percorso.
2) Non hai nulla che non va
Può capitare che tu ti senta diverso dai compagni e che tu abbia paura di dirgli che hai delle difficoltà a leggere o scrivere o che tu ti possa vergognare a utilizzare gli strumenti compensativi in classe. Queste sensazioni non sono positive e possono complicare il tuo appuntamento quotidiano con la scuola. I disturbi specifici dell’apprendimento sono una tua caratteristica, non c’è niente in te che non vada, devi solo imparare a conoscerli ed è importante che anche i tuoi compagni riescano a capirti. Chiedi aiuto ai tuoi genitori, ai maestri e ai professori.
3) Scopri le tue difficoltà
Si chiama Disturbo Specifico dell’Apprendimento proprio perché riguarda delle specifiche abilità e non tutte. Scopri quali sono le tue difficoltà. Ad esempio, se fai fatica a leggere e a comprendere o ricordarti quello che hai letto, se fai fatica a memorizzare o ripetere ciò che hai studiato nonostante tu ti sia impegnato molto, se fai fatica a comprendere le consegne degli esercizi o delle verifiche… è infatti importantissimo conoscere e riconoscere le proprie difficoltà per capire meglio quali strategie utilizzare per compensarle. La diagnosi darà infatti una mano alle maestre e ai professori, ma poi solo tu potrai capire esattamente cosa ti può essere utile.
4) Scopri le tue qualità
Non ti concentrare troppo o solo sulle difficoltà e scopri invece anche i tuoi punti di forza. Per esempio, hai una memoria più visiva, ti trovi bene utilizzando i colori, hai molta fantasia e sai inventare dei bei racconti, c’è qualcosa che ti piace molto e ti appassiona per cui riesci a compensare autonomamente le difficoltà che normalmente hai nel fare altre cose che sembrano piacerti di meno? Questi sono solo degli esempi, ma prova a concentrarti e pensare a tutte le cose che ti riescono bene o in cui ti senti sicuro. Una volta trovate possono essere i punti sui quali costruire un metodo tutto tuo che ti aiuti nelle cose in cui al momento fai più fatica.
5) Scopri gli strumenti compensativi
Lo sai che esistono tantissimi programmi per lo studio? Ad esempio, c’è una voce che si chiama sintesi vocale con la quale puoi leggere con le orecchie i libri. Ci sono i libri di scuola in formato PDF aperto nella biblioteca digitale LibroAID in modo che tu possa leggere con le orecchie anche quelli. Ci sono dei programmi con i quali puoi costruire delle mappe concettuali che potranno aiutarti sia nella fase di studio che quando dovrai affrontare le interrogazioni o i compiti in classe. Ci sono delle app apposta per poter prendere appunti, fare foto alla lavagna e registrare le lezioni. Ci sono anche tantissimi audiolibri, anche gratuiti, per permetterti di leggere tanti libri di narrativa. Sono tutte risorse che possono aiutarti a fare meno fatica e a impiegare meno tempo nel tuo impegno quotidiano, in modo che ti resti dello spazio per fare ciò che più ti piace. Prova a visitare il sito dell’AID e di Erickson e a cercare l’elenco dei software compensativi, sperimentali e prova a capire quale farebbe a caso tuo.
6) Sperimenta diverse strategie
Non esiste una ricetta uguale per tutti, perché ciascuno ha il proprio stile di apprendimento. Non ti scoraggiare quindi se senti che la strategia trovata da qualche tuo amico non va bene per te, perché tu devi trovare quella adatta a te. All’inizio può sembrare faticoso ma se troverai quella giusta vedrai che poi tutto inizierà a diventare meno difficile e più divertente. Puoi anche pensare di farti aiutare da qualcuno, esistono infatti dei doposcuola fatti apposta per questo, dove ci sono dei tutor specializzati nell’uso degli strumenti compensativi e possono aiutarti a capire quali fanno a caso tuo e possono aiutarti a costruire il tuo metodo di studio. Prova a chiamare l’Associazione italiana Dislessia per scoprire quali risorse ci sono nella tua città.
7) Usa ciò che ti piace per apprendere meglio
A volte studiare può sembrare un appuntamento noioso, ma non deve per forza essere così. Ci sono un sacco di risorse per studiare in modo più divertente, ad esempio dei canali video come bignomi o repetita didattica, o altre risorse come le canzoni matematiche su youtube o le canzoni rap, come il rap delle ossidoriduzioni. Per studiare l’inglese ad esempio sono ottime le canzoni che più ti piacciono, trovi dei video in cui compare anche il testo ed è un ottimo allenamento per prendere familiarità con la lingua, per non parlare delle serie televisive, magari quelle che hai già visto in italiano puoi rivederle in lingua originale con i sottotitoli.
8) Impara ad organizzare il tuo tempo
Abbiamo già detto che utilizzare gli strumenti e trovare un buon metodo di studio può aiutarti ad avere più tempo libero per poter fare ciò che ti va. È importante però che impari a organizzarti bene, a capire quanto tempo richiede il tuo appuntamento quotidiano con i compiti e lo studio. Importante è anche capire per quanto tempo riesci a mantenere la concentrazione, in modo che puoi programmare lo studio anche in base a questo, prevendendo eventualmente delle piccole pause ristoratrici che ti aiutino a ricaricarti prima di ricominciare a studiare. Oltre all’organizzazione del tempo ricordati anche di trovare delle strategie per organizzare il materiale che devi portare a scuola. potresti creare ad esempio un calendario con un codice colori o dei disegni per ogni materia per poter controllare di avere sempre ciò che ti serve sia a scuola che nel momento dei compiti.
9) Aiuta gli insegnanti e i genitori a comprenderti
A volte per gli adulti non è facile capire cosa stai provando, quali sono le tue difficoltà e di cosa avresti bisogno. Cerca di aiutarli a capire e a capirti, in modo che ti possano aiutare, soprattutto di fronte alle tue difficoltà. Se per esempio ti stai impegnando tanto ma non arrivano i risultati che tu speri non ti scoraggiare e cerca di parlarne con chi sta vicino per capire meglio cosa ti può essere utile. Ricorda che i percorsi a volte sono lenti, ci vuole tempo per riuscire a trovare un equilibrio, ma confrontandoti con gli altri tutto può diventare più semplice.
10) Se qualcosa non sta andando bene parlane
Se ti senti un po’ triste o arrabbiato quando vai a scuola, se non vai d’accordo con i tuoi compagni, se non puoi usare gli strumenti che a te servono parlane con i tuoi genitori o con chi ti sta vicino in modo che possano aiutarti e che tutto si sistemi. È infatti importante che tu ti senta bene, sicuro e a tuo agio. A volte si fa fatica a dire ciò che si pensa, ci si vergogna o si pensa che nessuno possa capirci: non è così, non ti preoccupare e dai la possibilità a chi ti sta vicino di aiutarti a stare bene se qualcosa non va.
Leggi di più
Silvia Manni, presidente della sezione AID di Taranto, racconta la sua esperienza personale di mamma di quattro ragazzi con DSA alle prese con la Didattica a Distanza
In questa emergenza in cui tutti siamo stati catapultati, nostro malgrado, mi ritrovo ad affrontare in modo amplificato una sfida che fino a un mese fa credevo aver superato quasi del tutto. Ovvero donare ai miei quattro figli con Disturbi Specifici di Apprendimento motivazioni, opportunità e strategie individualizzate mirate a uno studio efficace e sereno. Ho speso giorni, mesi e anni per trovare insieme ai loro docenti, i canali, le modalità e gli strumenti a loro più congeniali, e oggi improvvisamente e inaspettatamente tutto questo deve essere rielaborato e riadattato.
Due dei miei figli vivono la realtà universitaria, uno frequenta la scuola superiore e l’ultimo la scuola primaria. Tutti e quattro hanno difficoltà a organizzare e pianificare il tempo in tutti gli ambiti della propria vita.
La nostra giornata prima del coronavirus era scandita da schemi, programmi e orari acquisiti e ben regolati che sono stati stravolti e questo ha disorientato i miei ragazzi.
Pertanto è stato necessario decidere insieme uno schema della giornata vissuta in quarantena, per poter dare ritmo, ordine, ciclicità e trarre da questa organizzazione un’opportunità per sfruttare al meglio la nostra stretta convivenza.
È stato indispensabile creare turni di lavoro ben scanditi per la cura e l’igiene personale e della casa. Ma anche prevedere tempo di gioco comune, rispolverando i classici di società come Monopoli e i giochi di ruolo. Sessioni di fitness, giardinaggio ed economia domestica con la mamma, lezioni di musica e attività di bricolage con il papà.
Molto tempo è organizzato per stare insieme e solo un’ora il pomeriggio e due la sera di tempo libero individuale.
Naturalmente una porzione importante della giornata è dedicata alla didattica a distanza.
Per i ragazzi universitari procede abbastanza bene, hanno la maturità e la motivazione a seguire in autonomia le lezioni on line, ma non senza difficoltà, in quanto devono prendere con rapidità appunti di concetti o formule nuovi in contemporanea alla spiegazione in diretta. Successivamente fanno un lavoro di decodifica con modalità ritagliate sulle loro esigenze e già collaudate.
Molta difficoltà invece la viviamo con i figli più piccoli, che sono destabilizzati da questo totale cambiamento della didattica. Il loro umore, il ritmo del sonno ma soprattutto la motivazione ad apprendere, sono mutati.
Il Piano Didattico Personalizzato, concertato e applicato a regola d’arte durante l’anno scolastico, nella didattica a distanza è venuto a mancare quasi del tutto. Dopo una prima fase di osservazione e analisi delle difficoltà riscontrate, negli ultimi giorni abbiamo iniziato a fare proposte concrete, aiutando i docenti a trovare sistemi per risolvere le criticità riscontrate.
È stato difficile sfatare il mito che utilizzare il Pc per un ragazzo con DSA sia la panacea per tutti i mali.
Ci siamo ritrovati a barcamenarci tra link, video YouTube, videoconferenze annunciate e comunicate anche in tempi ridottissimi, un’ora per l’altra. Ogni docente utilizza una piattaforma diversa, con consegne da rispettare entro date e ore stabilite, su registro elettronico, mail istituzionali, e gruppi Whatsapp o Telegram creati dagli insegnanti in questi giorni. Questo genera confusione e disorientamento. Recuperare tutte le risorse sparpagliate ovunque è stato un lavoro difficile ed estenuante. Alcuni docenti inviano delle audiolezioni, ma per i miei ragazzi non sono immediatamente fruibili: con delle applicazioni di dettatura/trascrittura, siamo costretti a trasformarle in forma scritta per estrapolarne regole, formule e concetti.
Tutto questo ha portato nei miei figli, irritabilità, un atteggiamento di “evitamento”, rimandando il più possibile momento di fare i compiti, e mancanza di motivazione.
Un altro aspetto non marginale che stiamo vivendo è il cyberbullismo, durante le videolezioni collettive. Accade che i ragazzi oscurino le telecamere, neghino l’accesso ad altri o mettano in muto i compagni, creando un clima negativo, poco collaborativo e con tensioni con i docenti. L’accavallarsi delle voci crea molta distraibilità e difficoltà di concentrazione; le interrogazioni avvengono senza programmazione, senza poter avere il tempo di usare schemi, mappe e appunti.
Dopo questa prima fase davvero difficile, pian piano stiamo provando insieme ai genitori e ai docenti a proporre agli alunni consegne in power point, videolezioni in gruppi ristretti di 4/5 alunni per volta e . Tutto questo per alleggerire stati di ansia, ridurre la distraibilità e per innalzare l’autostima e la sensazione di autoefficacia degli studenti.
Come sempre la carta vincente è l’empatia, il contatto docente-alunno, il potersi guardare anche attraverso un monitor, occhi negli occhi, passandosi sorrisi, emozioni, fiducia, incoraggiamenti, approvazioni e fiducia. Molto efficace è stato indurre i miei ragazzi a mettersi nei panni dei loro docenti.
A immaginare che anche loro si sono trovati catapultati in una realtà inedita, costretti a stravolgere totalmente la didattica, le loro sicurezze, a dover studiare, sperimentare, rielaborare e trovare nuovi sistemi di insegnamento, con una responsabilità incredibile nei confronti dei loro alunni, colleghi e dirigenti scolastici. È stato importante per loro riuscire a calarsi nelle difficoltà di un docente che deve allo stesso tempo occuparsi, oltre che degli alunni, della propria famiglia, delle proprie paure, di come gestire meglio la didattica a distanza. Molto spesso hanno genitori anziani, malati da accudire, devono fare i conti con gli sbalzi di umore di una vita confinata in casa, sono come tutti disorientati.
Questo, nella mia esperienza di madre di ragazzi con DSA, ha fatto la differenza. Io per prima ho rivisto il mio ruolo genitoriale. Sottolineare il lato umano è stato importante, perché i miei figli si sono sentiti riconoscenti e rispettosi del tempo e della qualità del tempo che i loro insegnanti stanno offrendo loro.
Certamente con il passare dei giorni iniziamo ad acquisire e automatizzare nuove competenze e vivere questa sfida come una nuova opportunità per migliorarci come persone. Stiamo imparando a essere sostegno l’uno per l’altro vivendo la famiglia e la scuola come comunità in cui ognuno nel suo ruolo è essenziale.
Leggi di più
La DAD ha posto diverse sfide e difficoltà a docenti, famiglie e ragazzi con DSA.
L’emergenza Coronavirus ha messo la scuola, i ragazzi e le famiglie a dura prova. Ma, malgrado tutto, ha dato vita a sperimentazioni di massa che saranno senz’altro utili per il futuro quando, si spera presto, si tornerà alla normalità. I computer, le piattaforme, d’ora in poi faranno parte dell’insegnamento, come quello in presenza sui banchi di scuola.
La Didattica a Distanza per moltissimi docenti, abbastanza digiuni di informatica, è stata una vera e propria sfida, ma molti l’hanno raccolta. Non è stato facile catturare l’attenzione dei ragazzi, riuscire a essere efficaci e attenti ai bisogni di ciascuno, non solo alle difficoltà degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, ma a quelle dei ragazzi che non sanno usare un computer, che magari non hanno una famiglia in grado di assisterli, o addirittura privi della connessione Internet.
La Didattica a Distanza in molti casi ha acuito le differenze sociali e culturali.
I ragazzi e i bambini soffrono tra l’altro una vita costretta in spazi ristretti, l’assenza di amici e compagni; i più piccoli la mancanza del rapporto empatico con le maestre e i maestri. Le famiglie fanno quello che possono, spesso perdono ore a fotografare o scannerizzare compiti, ad aiutare i figli a connettersi alle varie piattaforme, alle chat di Whatsapp con i docenti o interrogazioni su Skype. Tutto magari cercando di conciliare questo impegno extra con il lavoro da casa, anch’esso a distanza. O celando l’angoscia per il lavoro che non c’è, un parente malato o peggio. Il pomeriggio e la sera padri e madri si dedicano a creare attività insieme ai figli, diverse dallo studio, per distrarli, tenerli occupati e dare loro una parvenza di normalità.
Ė questo che vi racconteranno, offrendovi molti spunti di riflessione, alcune testimonianze che abbiamo raccolto: quella di Giovanna Fola, una docente, formatrice AID e madre di una ragazza dislessica, una donna capace quindi di vedere il problema da due punti di vista diversi; e quelle di tre presidenti AID, rel="noopener noreferrer" madri di figli con DSA: Stefania Zini di Bologna, Paola Ruffini di Teramo e Silvia Manni di Taranto.
L’Associazione Italiana Dislessia, inoltre, sul proprio sito www.aditalia.org ha pubblicato diversi articoli e video sulla DaD che offrono consigli e materiali utili sia agli insegnanti che ai genitori.
Leggi di più
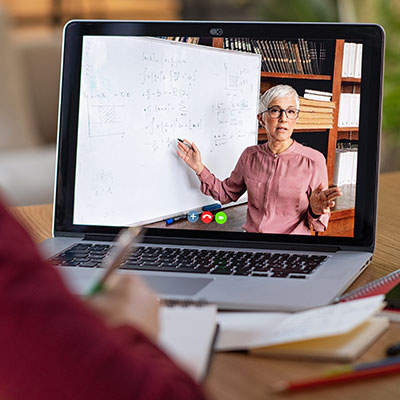
.jpg)



