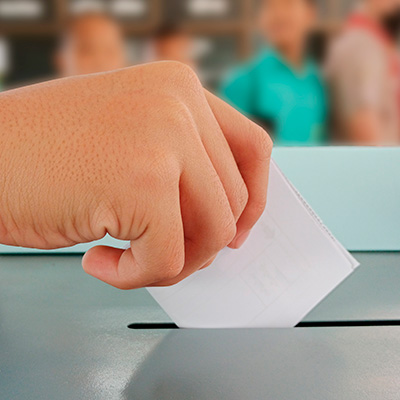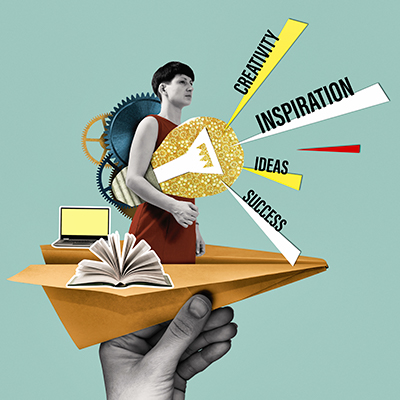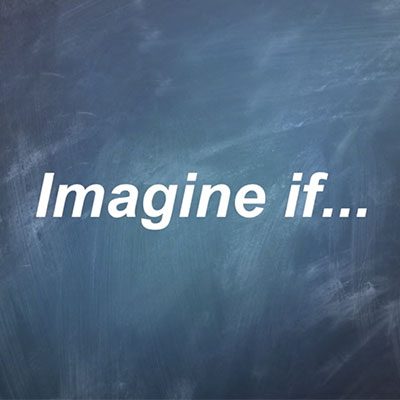Accedi/registrati
Entra nel
Mondo Erickson
Mondo Erickson
Entra In Erickson
Informazione obbligatoria
Non sei ancora un utente registrato? Registrati ora.
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e da
Privacy Policy e
Terms of Service di Google
I mini gialli dei dettati 2
Carrello
Spedizioni veloci
Pagamenti sicuri
Totale:
Il tuo carrello è vuoto
|***
Libro
Quantità:
Filtra per categorie
Tematica (1)
Argomento
Utile in caso di
Filtra
Risultati trovati: 54
Anche a scuola è importante esercitare il senso critico per rendere bambini e bambine, ragazzi e ragazze cittadini partecipi attivamente della democrazia
Alcuni anni fa un insigne costituzionalista, già presidente della Corte costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, segnalava con parole accorate il fatto che l’educazione civica fosse stata gradualmente emarginata. Ribadiva all’opposto che non si dà democrazia se non la si coltiva.
In questo senso, la nostra società ha più che mai bisogno di scuola; ha bisogno di un luogo «salvo» - come lo definiva Giuseppe Deiana nel suo libro Insegnare l’etica pubblica - in cui tutti i giovani possano sviluppare la passione del conoscere e del vivere civile e, con ciò, condividere i valori della democrazia partecipata.
La democrazia, infatti, è quella forma di governo della cosa pubblica che richiede una diffusa partecipazione dei cittadini in grado di esercitare il senso critico.
L’esercizio del senso critico è fondamentale per distinguere la democrazia da altri modi di organizzazione politica caratterizzati da un coinvolgimento di massa.
Il termine «critico» è fondamentale non solo per distinguere la democrazia da sistemi politici totalitari, nei quali colui che dissente è perseguito come nemico della società, ma soprattutto da quelle democrazie che appaiono, per così dire, assopite. In queste ultime la democrazia si è ridotta al semplice principio maggioritario, per il quale chi ottiene la maggioranza dei consensi è legittimato a esercitare il potere, al di là di ogni critica.
Educare alla cittadinanza assume invece un’idea di democrazia presa sul serio che non può fare a meno di persone consapevoli di essere portatori di diritti e doveri.
Come creare questa consapevolezza? Nella società rendendo remunerativo il fatto di esercitare i diritti e i doveri della cittadinanza; nella scuola interiorizzando l’ethos della democrazia.
Insegnare la democrazia non è riducibile a quelle forme di educazione civica che, in passato, si limitavano a una informazione sommaria sulle istituzioni. Occorre che l’educazione civica si apra all’interiorizzazione di una serie di principi che costituiscono l’ethos della democrazia, che consiste in dedizione alla cosa pubblica e disponibilità a destinarvi le proprie energie.
È, quindi, il concetto di cittadinanza attiva che si vuole sviluppare nei vari ambiti in cui si articola e si svolge la vita delle persone.
Da un punto di vista educativo l’approccio alla cittadinanza corrisponde all’esigenza di fornire alle nuove generazioni conoscenze e modi di rapportarsi alla realtà globale, ove occorra, con il linguaggio del rischio o dell’incertezza. Si tratta di un lavoro educativo che è indispensabile iniziare dalla scuola primaria, accanto ai cosiddetti saperi di base, per evitare che si fissino strutture mentali persistenti per le quali l’etica pubblica è un «bene» superfluo per l’individuo e per la società.
Leggi di più
Fare antropologia a scuola permette di sviluppare uno sguardo consapevole su un mondo che continua a cambiare e imparare ad adattarci ad esso
Nel nostro Paese, il 2017 è stato un anno decisivo per il rapporto tra antropologia e mondo dell’istruzione. In quell’anno, infatti, tale disciplina, poco conosciuta fuori dal contesto universitario o specialistico, è diventata rilevante, in quanto indicata tra i requisiti di base per diventare docenti nella scuola pubblica italiana: improvvisamente l’antropologia è uscita dal suo stato di relativo «anonimato» ed è entrata a far parte a tutti gli effetti delle discipline cardine dei percorsi riguardanti l’istruzione e l’educazione.
Questo perché l’antropologia è, senza ombra di dubbio, una delle discipline che maggiormente aiutano a sviluppare uno sguardo critico e consapevole sui mutamenti del nostro mondo.
I bambini e i giovani sono i soggetti più sensibili ed esposti ai continui cambiamenti culturali, tecnologici e relazionali che caratterizzano la nostra epoca; e la società globalizzata di oggi esige, in particolar modo da chi in essa si trova a crescere, capacità critica e disponibilità ad adattarsi tanto alle evoluzioni tecnologiche quanto alle nuove dinamiche relazionali — spesso di tipo conflittuale — tipiche dei molteplici mondi culturali nei quali siamo immersi.
Negli ultimi decenni, l’uso massiccio delle tecnologie digitali e dei social network ha modificato le relazioni interpersonali all’interno delle comunità nelle quali trascorriamo il nostro tempo; i ragazzi possono accedere a un vastissimo patrimonio di informazioni, vedere migliaia di immagini e vagliare quantità sterminate di dati servendosi esclusivamente del telefono cellulare. Queste opportunità, agendo in modo sinergico tra loro, hanno determinato e determinano, su più livelli, conseguenze culturali, comunicative e sociali che vanno ascoltate.
Attivare percorsi di educazione interculturale nelle scuole di ogni ordine e grado è di primaria importanza al fine di soddisfare un bisogno educativo che spesso rimane inascoltato, di preparare i futuri cittadini a riconoscere le diversità e i valori e a osservare, rilevare e risolvere situazioni di conflitto, di coltivare e promuovere valori di tolleranza e di riconoscimento dei diritti umani universali. Le conseguenze dei fenomeni globali delle migrazioni sulle culture e sui sistemi istituzionali — i quali non sono altro che riflessi della nostra società e del nostro modo di pensare — rappresentano solamente uno dei molti aspetti che l’antropologia aiuta a indagare e analizzare.
Esplorare il mondo dell’antropologia è un modo per arricchire il proprio bagaglio culturale e una strategia per uscire dal nostro «guscio» e volgerci alle altre società e alla diversità con uno sguardo più consapevole, preparato e curioso.
Oltre a guardare verso l’esterno e verso gli Altri, però, impariamo a guardare noi stessi: fare antropologia è anche sviluppare capacità di autoanalisi, imparare a volare per un po’ al di fuori del nostro io e delle nostre idee e convinzioni e a osservarci con gli occhi di un estraneo che ci incontra per la prima volta.
Leggi di più
Le abilità interculturali costituiscono la base delle altre competenze, per questo è importante trovare i giusti strumenti per valutarle efficacemente.
Il problema della valutazione degli alunni nella scuola è di grande attualità. In questi anni più volte sono stati messi in discussione il sistema di valutazione, i criteri su cui si basa e i suoi strumenti applicativi. La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni che frequentano la scuola primaria è stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il concetto di voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, educazione civica compresa.
Oltre alle varie competenze disciplinari e linguistiche, uno dei principali obiettivi attesi è lo sviluppo della competenza interculturale. Dal documento pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea» il 4 giugno 2018 si evince che, pur essendo le competenze ritenute tutte di pari importanza, «elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave» (4.6.2018 IT, «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» C 189/7).
Le «abilità interculturali», dunque, rientrano tra le basi fondamentali per lo sviluppo delle altre competenze.
A questo punto dovremmo chiederci: come possiamo valutare i nostri alunni in attività di tipo interculturale? Quali strumenti e principi dobbiamo utilizzare?
Servono, infatti, soprattutto nuovi strumenti: rubriche valutative che tengano conto del percorso di ciascun alunno, guardando a lui/lei come a un individuo partecipe e attivo nella scuola e nella società. I dati rilevati devono essere confrontati e, in base al giudizio dell’insegnante, va stabilito il livello di acquisizione per ogni componente specifico della vasta competenza interculturale: si tratta, ad esempio, di valutare negli studenti la capacità di pensiero critico, il livello di partecipazione alle attività, i prodotti realizzati, l’interesse dimostrato, l’originalità degli interventi.
Leggi di più
Che cosa hanno in comune il processo creativo e quello del cambiamento?
Le capacità creative dell’essere umano ci hanno procuratobenefici enormi nel corso della storia in termini di comodità della nostra vita,salute del nostro corpo e complessità delle nostre culture.Ma allo stesso tempo ci hanno condotti a un punto critico: il mondo sta attraversando cambiamenti rivoluzionari.
La rivoluzione di cui abbiamo bisogno richiede di resettare completamente i nostri sistemi sociali, richiede di avere una nuova e più ampia concezione delle capacità umane e di abbracciare la ricchezza della diversità dei talenti. Si basa sul credere nel valore dell’individuo, nel diritto all’auto-determinazione, nel nostro potenziale di evoluzione e nell’importanza della responsabilità civica e del rispetto per gli altri.
E soprattutto questa rivoluzione parte dall’istruzione.
L’istruzione efficace è sempre un equilibrio fra rigore e libertà, tradizione e innovazione, individuo e gruppo, teoria e pratica, mondo interiore e mondo esteriore. C’è bisogno urgente di trovare questo equilibrio. Per farlo ci vogliono coraggio e immaginazione e abbiamo entrambi in abbondanza.
Per cambiare il mondo occorre agire e si comincia da se stessi: quello che succede nelle scuole ha effetti diretti su ognuno, perché influenza le generazioni di bambini e ragazzi che un giorno modelleranno la società.
In questo senso ognuno di noi è coinvolto nell’istruzione, - che sia uno studente, un genitore, un insegnante, un amministratore o un imprenditore, - e ha la possibilità di attuare un cambiamento.
Il punto migliore da cui partire per iniziare a pensare a come cambiare l’istruzione è esattamente quello in cui si è.
Se sei un insegnante sai che il tuo non è soltanto un lavoro o una professione: è una vocazione. Il modo migliore per compiere quotidianamente cambiamenti nel sistema scolastico è impegnarsi a usare la propria competenza per guidare gli studenti, aiutarli a trovare uno scopo e metterli nelle condizioni di credere in se stessi.
Se sei un dirigente scolastico il tuo scopo dev’essere quello di creare una comunità nella quale tutte le persone che ne fanno parte condividano gli stessi obiettivi. Per farlo devi essere in grado di guardare oltre le convenzioni fossilizzate del sistema.
Se sei un genitore hai il compito di sostenere tuo figlio e creare le opportunità per lui di scoprire e seguire la propria strada. Tuo figlio avrà maggiori probabilità di farlo se eviterai di pensare che tutta la responsabilità della sua istruzione sia della scuola e degli insegnanti, ma che questa si integra con gli aspetti della vita familiare. Attivati quindi per creare una relazione sana e positiva con il sistema scolastico, partecipando attivamente alla cultura della scuola.
Se sei uno studente devi sapere che l’intero sistema educativo è fatto per te, anche se spesso hai la sensazione che non sia così. Tra tutti i soggetti coinvolti nel cambiamento del sistema scolastico tu e i tuoi compagni siete quelli per i quali la posta in gioco è più alta. Avete già iniziato a dimostrarci che siete appassionati e determinati con i grandi movimenti per i diritti delle persone e dell’ambiente. Per attuare un radicale cambiamento è essenziale che conosciate i vostri diritti e che usiate l’era di grande connessione che state vivendo per farli valere.
Per nessuno il passaggio dall’idea al cambiamento è facile: come quello creativo, anche quello del cambiamento è un processo costante di azione, improvvisazione, valutazione e ri-orientamento, alla luce dell’esperienza e delle circostanze. Le idee che stanno dietro a questa rivoluzione non sono nuove, ma stanno prendendo sempre più forza: creiamo i mondi in cui viviamo e possiamo ri-crearli.
Leggi di più
Un’insegnante della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Rodari Alighieri Spalatro” di Vieste racconta il progetto sviluppato con i suoi alunni in memoria di Sir Ken Robinson
La scuola non è una catena di montaggio, gli alunni sono tutti “pezzi unici”!
Entrano nella scuola molto piccoli, ognuno con la sua personalità e con i suoi talenti, spesso ancora nascosti (anche a se stessi) e, in molti casi, ne escono impoveriti di immaginazione e creatività. Il percorso di studi è fin da subito, per tutti, rigido e abbastanza scontato almeno fino ai 13 anni. Quando finalmente diventano liberi di scegliere il loro indirizzo di studi, le cose paradossalmente peggiorano: il sistema si fa ancora più rigido e salgono i numeri della dispersione scolastica. Certificazioni e diplomi, conseguiti (spesso a fatica) al termine del percorso scolastico, dovrebbero raccontarci chi è e cosa sa fare quel piccolo uomo o quella piccola donna che stiamo per consegnare alla vita da adulto con gli strumenti (si spera) per poterla affrontare, ma spesso quei numeri e quelle parole non raccontano la verità. Come è possibile testare le competenze di un ragazzo o una ragazza adottando metodologie didattiche per lo più tradizionali e basandoci su un sistema di insegnamento e apprendimento (anacronisticamente, ahimè) nozionistico? Come è possibile farlo o farla appassionare alla scuola puntando solo sulla motivazione estrinseca, cioè l’ottenimento di buoni voti e del famigerato pezzo di carta? La standardizzazione dell'insegnamento contro cui sir Ken Robinson, anglosassone di nascita ma vissuto a lungo negli States, si è battuto per tutta la vita, checché se ne dica, è ancora molto forte anche da noi e continua a far danni.
Tutti conoscono Ken Robinson, i suoi Ted Talks hanno raggiunto visualizzazioni record! Il suo mantra? La scuola (così com'è) uccide la creatività, occorre cambiare i paradigmi dell'educazione!
L'eredità che ci ha lasciato quest'uomo è preziosa, i suoi libri (editi in Italia da Erickson) dovrebbero essere letti da tutti gli educatori. Attenzione però, perché leggere Ken Robinson (il mio preferito è “The Element”) può avere effetti collaterali! Il suo messaggio, infatti, è rivoluzionario e chiama in causa tutti gli insegnanti. Le rivoluzioni, dice Robinson, non aspettavano direttive, vengono dal basso.
L'istruzione è la nostra grande speranza, un'istruzione nuovo stile, adeguata alle sfide che abbiamo davanti a noi e ai veri talenti che tutti noi abbiamo dentro, si legge in “Scuola creativa”. I talenti, le passioni, quelli che troppo spesso la scuola ignora o sottovaluta, dovrebbero essere invece il punto di partenza, la scintilla per accendere nei nostri studenti l’amore per la conoscenza, la rampa di lancio della loro creatività. Per come la vedo io, rincara Robinson, lo scopo dell'istruzione è mettere gli studenti nelle condizioni di comprendere il mondo che li circonda e i talenti che hanno dentro di sé così che possano diventare persone realizzate e cittadini attivi e compassionevoli.
Per celebrare Ken Robinson, io e i miei studenti della classe 1a B dell’Istituto Comprensivo “Rodari Alighieri Spalatro” di Vieste, siamo partiti da qui. Il modo in cui egli stesso si è presentato, tramite i suoi video, lo ha reso subito simpatico a tutti. La sua ironia oltrepassa le barriere linguistiche e la sua visione di scuola apre orizzonti mai immaginati prima, accende speranze tra chi è seduto nei banchi, ancor più in questo difficile tempo di pandemia. E allora, come lo stesso Ken ci avrebbe esortato a fare, abbiamo usato la nostra immaginazione per rappresentare, attraverso un video, la scuola ideale. Ognuno ha parlato delle sue passioni, scoprendo inaspettatamente di condividerle con altri. Se la scuola riuscisse ad assecondare le inclinazioni di tutti, è il messaggio dei ragazzi, sarebbe più bello andarci! Ma il loop alla fine si interrompe e salta fuori qualcosa di inaspettato. È lo spunto per lanciare un appello alla scuola, agli insegnanti, agli adulti.
Grazie a Ken Robinson per averci fatto divertire, immaginare e sperare una scuola migliore!
Leggi di più
Un’insegnante della Fondazione Istituto Marymount di Roma racconta il progetto sviluppato con gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria in memoria di Sir Ken Robinson
La creatività è sempre stata al centro della mia attività didattica. Ho avuto l’opportunità di ascoltare dal vivo Sir Ken Robinson qualche anno fa al Bett Show di Londra. Da allora ho fatto mio quanto diceva che bisogna offrire occasioni frequenti ai bambini e ai ragazzi di allenare la loro creatività. Allenare perché tutti siamo persone creative, ma col passare del tempo ne perdiamo la pratica. La creatività è invece importantissima perché è quella dote che ti permette di affrontare i problemi quotidiani della vita, e soprattutto di rialzarti anche nei momenti più duri. La partecipazione a “Imagine If…” è stata un’opportunità di esercitare la creatività per i bambini della nostra scuola, Fondazione Istituto Marymount di Roma.
La concomitanza con il cambio di valutazione e la fine del quadrimestre mi ha convinto a presentare la proposta come libera sia ai colleghi che ai bambini, chi ha avuto la possibilità ha partecipato, per chi non è riuscito stavolta costruiremo sicuramente altre occasioni.
Ne abbiamo bisogno per costruire il nostro futuro, sono i nostri bambini di oggi che dovranno inventare soluzioni per il mondo che noi abbiamo costruito per loro, e non abbiamo fatto proprio questo gran lavoro… quindi cerchiamo di offrire loro ogni occasione possibile perché possano esprimere le loro idee.
In questo progetto una bambina di 5 anni alla domanda “Che cos'è la creatività secondo voi?”, ha risposto “La creatività è quella cosa che ispira la nostra immaginazione a fare cose”, ecco per me in questa frase c’è davvero l’essenza di tutto.
https://spark.adobe.com/page/9rzi7XPR4PvSj/
Leggi di più