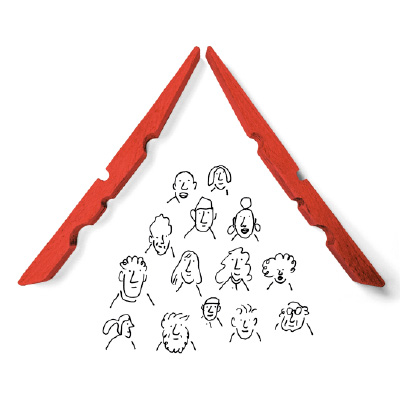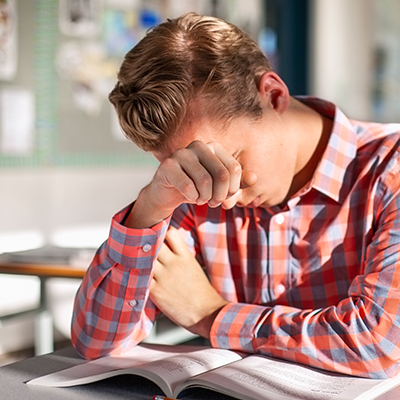Accedi/registrati
Entra nel
Mondo Erickson
Mondo Erickson
Entra In Erickson
Informazione obbligatoria
Non sei ancora un utente registrato? Registrati ora.
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e da
Privacy Policy e
Terms of Service di Google
I mini gialli dei dettati 2
Carrello
Spedizioni veloci
Pagamenti sicuri
Totale:
Il tuo carrello è vuoto
|***
Libro
Quantità:
Filtra per categorie
Tematica
Argomento
Utile in caso di
Filtra
Risultati trovati: 22
La creazione di un clima scolastico positivo è il presupposto per soddisfare i bisogni di alunne, alunni e insegnanti e promuovere lo sviluppo di competenze
La scuola è un ambiente in cui bambine, bambini e adolescenti possono da una parte sviluppare le competenze necessarie per affrontare le sfide sociali, lavorative, personali della vita fuori dalla scuola, e dall’altra soddisfare i bisogni di appartenenza, accudimento e riconoscimento del proprio valore. Ciò presuppone un clima scolastico positivo e la promozione del benessere socio-emotivo di insegnanti, bambine, bambini e adolescenti, entrambi presupposti necessari per l’apprendimento. Daniela Lucangeli sottolinea che ciò che impariamo si fissa nel cervello insieme alle emozioni: “se un bambino impara con curiosità e gioia, la lezione si inciderà nella memoria insieme alla curiosità e alla gioia. Se impara con noia, paura, ansia, si attiverà l’alert: la risposta della mente trasmetterà il messaggio «Scappa da qui, perché ti fa male».
Un clima scolastico positivo è una di quelle cose difficili da definire e misurare, ma tutti, genitori compresi, lo riconoscono quando lo vedono. Lo stato delle strutture scolastiche, il tono delle conversazioni nei corridoi, il modo in cui alunni e alunne interagiscono tra di loro, l'entusiasmo del personale scolastico sono alcuni dei segnali indicativi del clima scolastico. Il clima scolastico influenza il benessere socio-emotivo di alunni e alunni. Per misurare il clima scolastico e il benessere di studenti e studentesse, OCSE PISA usa indicatori che si riferiscono al contesto scolastico, in particolare il clima collaborativo: studenti e studentesse ottengono punteggi più alti in lettura quando c’è cooperazione tra compagni. In Italia, il 48% dei quindicenni ha riferito che i propri compagni di scuola collaborano tra di loro (media OCSE: 62%). Gli altri indicatori misurati da OCSE PISA includono: sentirsi solo/a a scuola (nel 2018 circa il 12% dei quindicenni italiani ha dichiarato di sentirsi solo a scuola), essere vittima di bullismo (in Italia il 24% dei quindicenni ha dichiarato di essere vittima di bullismo almeno qualche volta al mese), saltare giorni di scuola e arrivare in ritardo (il 21% ha saltato una giornata di scuola nelle due settimane precedenti PISA e il 48% è arrivato in ritardo).
OCSE PISA usa inoltre degli indicatori del benessere di studenti e studentesse, che non si riferiscono specificamente al contesto scolastico. Questi indicatori sono comunque rilevanti perché gli adolescenti trascorrono gran parte del loro tempo a scuola e i loro compagni e compagne giocano un ruolo preminente nella loro vita sociale. In Italia il 67% degli studenti e studentesse ha dichiarato nel 2018 di essere soddisfatto della propria vita e il 91% ha riferito di sentirsi felice qualche volta o sempre).
Nella maggior parte dei Paesi, i quindicenni sono più propensi a segnalare sentimenti positivi quando hanno dichiarato un più forte senso di appartenenza a scuola e una maggiore cooperazione.
In quasi tutti i sistemi educativi, anche in Italia, le ragazze hanno espresso unapaura di falliremaggiore rispetto ai ragazzi. Nella maggior parte dei sistemi scolastici, chi ha espresso una maggiore paura di fallire ha ottenuto punteggi più alti in lettura, ma ha riferito una minore soddisfazione per la vita, rispetto a chi ha espresso una minore preoccupazione di fallire. Infine, la maggior parte dei quindicenni dei Paesi OCSE ha una mentalità di crescita, cioè ritiene che le loro abilità e la loro intelligenza possa svilupparsi nel tempo (il 59% degli italiani; media OCSE 63%). Nei Paesi OCSE, la mentalità di crescita è stata associata positivamente alla motivazione ad affrontare compiti, all'autoefficacia, alla definizione di obiettivi di apprendimento e alla percezione del valore della scuola; è stata associata negativamente alla paura di fallire.
Il benessere degli insegnanti è sicuramente un fattore che influenza la loro soddisfazione lavorativa e l'entusiasmo per il loro lavoro. È correlato alla motivazione, ha un impatto i termini di qualità e rendimento, ed è un fattore chiave che influenza la motivazione e i risultati di studenti e studentesse.
I risultati PISA 2018 evidenziano che studenti e studentesse ottengono punteggi più alti in lettura quando percepiscono il loro insegnante come entusiasta e interessato alla materia. Circa il 74% degli studenti e studentesse italiane è d'accordo o molto d'accordo sul fatto che il loro insegnante mostri piacere nel fare lezione. Il benessere riguarda diversi aspetti della professione di insegnante: il carico di lavoro, le condizioni di lavoro, il senso di sicurezza, il supporto di colleghi, colleghe e dell’istituzione, gli aspetti relazionali con studenti e studentesse, con i genitori e altri soggetti coinvolti nella scuola e, naturalmente, l'apprezzamento della comunità più ampia. Se questi aspetti sono fonte di esperienze negative, l’insegnante può trovarsi in uno stato di esaurimento fisico ed emotivo, di stress e di burnout, e la loro salute mentale e fisica può risentirne. Diversi studi evidenziano lo stress come uno dei fattori che rendono particolarmente difficile la professione di insegnante. Un’analisi di Eurydice del 2021 rivela che in tutta Europa molti insegnanti soffrono di stress sul lavoro (in Italia circa il 35% degli insegnanti della scuola secondaria di I grado, contro una media UE del 47%). L'evidenza sembra indicare che i livelli di stress sono più bassi quando gli insegnanti lavorano in ambienti scolastici che percepiscono come collaborativi, quando si sentono sicuri di sé nel motivare gli studenti e nel gestire il loro comportamento e quando sentono di avere autonomia nel loro lavoro.
Non sono ancora disponibili i dati sull’impatto della pandemia e delle interruzioni scolastiche sul clima scolastico ed il benessere di insegnanti, studenti e studentesse. È ipotizzabile che abbia avuto un impatto negativo.
A Didattiche.2022 parleremo ampiamente di come creare un clima scolastico positivo e promuovere benessere a scuola.
Fonti
Lucangeli D., Cinque lezioni leggere sull’emozione di apprendere, Trento, Erickson, 2019
OECD, Pisa 2018 Results Combined Executive Summaries Volume I, II & III, OECD 2019
OECD PISA 2018 Nota Paese Italia
European Commission/EACEA/Eurydice, 2021. Teachers in Europe: Careers, Development and Well-being. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Leggi di più
Daniela Lucangeli approfondisce il tema della speranza dal punto di vista della psicologia spiegando quanto sia prezioso il suo ruolo, in particolare in questo periodo di pandemia
Durante l’autunno del 2020, mentre cercavo di fare un po’ di luce sulla «mente che sente» in relazione al periodo di pandemia, mi è arrivata una lettera meravigliosa da un signore di nome Giovanni, che mi ha spinta ad approfondire il tema della speranza.
«Cara Prof., io sono un anziano disabile, non mentale. Da sempre sono in carrozzina, anzi credo di essere nato con questo mio prolungamento. Non ho mai camminato. L’esperienza del camminare non ce l’ho, eppure io ho fatto tanta strada. Non ho avuto figli ma sono stato maestro per 35 anni e ho accompagnato ogni mio allievo a essere se stesso, a imparare a fare da solo. Oggi purtroppo, ahimè per età, sono solo un osservatore alla finestra. Vedo la vita passare, la vedo inciampare e la vedo perdersi. Allora io, cara Daniela, le regalo la mia analisi: il malessere, il dolore della mente di cui lei parla, io lo conosco bene. L’ho temuto, ne sono scappato tante volte, l’ho affrontato e riaffrontato, ho lottato e ho vinto. Sotto e ancora più sotto, alle fondamenta di questo dolore sta la mancanza di speranza. È lì che si deve cercare la causa del vuoto di luce che ci sta disorientando tutti. Accenda un po’ di consapevolezza nuova sulla speranza!»
Ho accolto volentieri l’invito accorato di Giovanni e ho cercato di indagare sull’argomento. Molte sapienze si sono occupate della spes, la parola latina per chiamare la speranza.
Nella ricerca scientifica non c’è, invece, una definizione univoca del concetto di speranza. C’è anzi una sorta di diatriba: che cos’è la speranza? Perché noi la proviamo? È un’emozione?
Diremmo che ci assomiglia, in effetti; eppure gli studi che se ne occupano da un punto di vista neurofisiologico dicono che non si tratta di una vera e propria emozione, perché non ha le caratteristiche tipiche di attivazione neurofisiologica.
Potremmo in un certo senso dire che i sentimenti (come l’amore o l’amicizia) indicano uno stato del sentire che si prolunga per tanto tempo nella nostra vita, mentre le emozioni uno stato del sentire istantaneo.
Potrebbe sembrare, allora, che la speranza sia un sentimento. Ma anche ammettendo che sia così, questa classificazione è davvero sufficiente?
Negli anni Novanta anche Charles Richard Snyder, esponente degli studi di Psicologia positiva, ha cercato (forse per primo) di fare un po’ di ordine negli studi sulla speranza, lavorando alla Theory of hope. Secondo questo ricercatore, la speranza appartiene al costrutto della motivazione, il che equivale a dire che la speranza è una molla che ci spinge ad agire, ma non come se noi fossimo passivi: ci attrae a sé in maniera proattiva. Secondo Snyder, le due qualità principali della speranza sono l’agentività (io sono agente della mia speranza) e il potere di procedere: io non soltanto agisco per raggiungere la speranza di qualcosa, ma so cambiare strada se vedo che mi sto allontanando dall’obiettivo, perché non posso perdere la speranza.
Dopo esserci domandati che cosa sia, dobbiamo chiederci: come ci fa sentire la speranza? Mary, una bambina di sette anni, risponde con queste parole: «Quando le speranze mi finiscono capita che piango di tristezza, ma quando ritornano capita che mi sento guarita». Noi, in sintesi, assumendo un punto di vista psiconeurobiologico, possiamo rispondere affermando che chi spera è più resistente alla frustrazione, è più resiliente, prova meno stress, ha maggiore flessibilità psichica e comportamentale, ha maggiore adattabilità, ha maggiori capacità prosociali ed è più facilmente benvoluto dagli altri, oltre a piacere a se stesso…
Leggi di più
L’isolamento e l’insicurezza hanno inciso pesantemente sullo stato emotivo dei più giovani: un gruppo di esperti spiega come fronteggiare al meglio l’emergenza dal punto di vista emotivo, psicologico e scolastico
L’isolamento e l’insicurezza diffusa generati dalla pandemia hanno favorito, tra bambini e adolescenti, l’insorgere di problematiche comportamentali, acuendo al contempo le situazioni di malessere psicologico preesistenti. Il disagio emotivo che i giovani hanno vissuto e stanno vivendo non si può trascurare né sottovalutare, se non vogliamo che l’emergenza sanitaria si trasformi anche in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi.
Se ne parla in “Bambini, adolescenti e Covid-19”: un libro, curato da Stefano Vicari e da Silvia Di Vara, in cui alcuni tra i massimi esperti del nostro Paese in tema di infanzia e adolescenza cercano di individuare strategie percorribili per salvaguardare il benessere emotivo, familiare e relazionale di bambini e ragazzi e per garantire una frequenza scolastica di qualità, anche e soprattutto per gli alunni con disabilità.
Ascoltiamo la voce di cinque autori del libro, che hanno presentato il loro contributo in una serie di interviste raccolte dal giornale l’Adige.
Questo browser non supporta gli iframe.
@media (min-width: 767px) {
.iframe-podcast_ME{
height:1050px;
}
}
@media (max-width: 767px) {
.iframe-podcast_ME{
height:2050px;
}
}
Leggi di più
Le cinque fasi di sviluppo di un meccanismo molto importante per gli scambi comunicativi e il benessere emotivo dei bambini
Fin dalla nascita, il bambino può essere considerato un essere attivo e organizzato, capace di inserirsi con successo in una rete di scambi comunicativi con le persone che lo circondano. Nel corso della crescita, grazie al supporto di adulti sufficientemente sensibili, il bambino inizia a maturare le abilità di autoregolazione emotiva. Queste abilità di autoregolazione risultano evidenti in età prescolare, ma continuano poi ad evolvere per tutta la vita.
Secondo la prospettiva ontologica proposta da Claire Kopp (1982), l’autoregolazione si sviluppa per fasi, ognuna con le sue caratteristiche peculiari.
Fase 1: modulazione neurofisiologica
Inizia con la nascita e termina verso il terzo mese. La capacità di autoregolarsi in questa fase può essere osservata nel modo con cui il bambino adotta delle strategie per autoconsolarsi a fronte di stimolazioni eccessive. Tra i meccanismi di modulazione neurofisiologica troviamo i riflessi tipici del neonato (come il pianto o la suzione), volti a diminuire i livelli di attivazione del sistema nervoso simpatico e i movimenti corporei da un lato, e allontanarsi dalla fonte che è all’origine del disagio dall’altro.
Fase 2: modulazione senso-motoria
Inizia intorno ai tre mesi e prosegue fino a 1 anno di vita. Il termine «senso-motorio» sottolinea le capacità sensoriali e motorie tipiche del bambino a questa età, che consentono di rispondere in maniera adattiva alle richieste ambientali. Il termine «modulazione» indica che c’è assenza di consapevolezza sul significato della situazione. In questo periodo le capacità attentive del bambino si sviluppano velocemente: un bambino al di sotto dei 3 mesi viene calmato attraverso l’intervento contenitivo dei genitori, mentre con un bambino di circa 4 mesi il genitore interviene distraendolo, ovvero facendogli notare uno stimolo nuovo nell’ambiente. Il ri-orientamento
attentivo, nasce in questo periodo evolutivo, ma rimarrà sempre una buona strategia di regolazione delle emozioni per l’individuo.
Fase 3: controllo
Va dai 12 ai 18 mesi. Il controllo richiede intenzione, capacità di discriminare ciò che è proibito da ciò che invece è accettato dall’ambiente.
Esso è caratterizzato dalla compliance all’autorità e dalla capacità di inibire il proprio comportamento prima della messa in atto dello stesso. In questo periodo, i bambini capiscono pian piano che il sé è diverso dall’altro e dagli oggetti. È necessario che il bambino internalizzi le ingiunzioni e i permessi dei genitori, prima di capire che è lui a controllare se stesso, acquisizione che avviene intorno ai 2 anni e consente il passaggio all’autocontrollo.
Fase 4: autocontrollo
Inizia dai 24 mesi. L’autocontrollo comprende la compliance di fronte alle richieste, la capacità di ritardare un’attività su richiesta esterna o propria e di comportarsi in accordo alle aspettative ambientali anche in assenza dei caregiver. La capacità di autocontrollarsi non richiede soltanto consapevolezza, ma anche la capacità di modificare il proprio comportamento a seguito del richiamo esterno; essa dipende in parte dallo sviluppo dell’inibizione e in parte dall’aver internalizzato i divieti genitoriali. L’autocontrollo ha comunque dei limiti. In primo luogo, il bambino non riesce a modulare il proprio comportamento in maniera flessibile alle nuove situazioni, perché l’autocontrollo è ancora legato alla possibilità reale e immediata di incorrere
in conseguenze negative.
Fase 5: autoregolazione
Tipica del bambino con età superiore ai 3 anni.
L’autoregolazione è caratterizzata dall’uso di strategie che coinvolgono introspezione e consapevolezza. L’autoregolazione coinvolge abilità come utilizzare delle regole per guidare il comportamento, mantenere un monitoraggio appropriato del comportamento e immaginare cosa il contesto possa aspettarsi.
Il linguaggio è fondamentale per raggiungere un pieno sviluppo delle capacità autoregolatorie; a 3-4 anni il bambino utilizza il linguaggio come una modalità per organizzare i propri contenuti emotivi, per iniziare a parlare delle emozioni e per autoregolarsi. Le competenze linguistiche si manifestano come un linguaggio interno che monitora il comportamento. L’uso del linguaggio interno rimarrà una strategia di regolazione delle emozioni e di ragionamento lungo tutto l’arco della vita. Con la crescita, il linguaggio sarà poi la base con cui il bambino costruirà le proprie visioni di sé che a loro volta diventeranno delle narrative, delle credenze che serviranno per regolare il proprio comportamento.
Leggi di più
Un’indagine svolta in collaborazione con il MIUR ci rivela che molti studenti dichiarano di non stare bene a scuola
Tempo fa è stata istituita una commissione ministeriale per lo studio del livello di benessere e malessere nelle scuole italiane, alla quale ho partecipato. Per ottenere una panoramica avevamo scelto di analizzare il benessere scolastico di un ampio numero di preadolescenti somministrando a loro e ai loro insegnanti dei questionari di rilevazione delle variabili psicologiche che puntavano a indagare il burn-out (esaurimento dovuto a uno stress che porta a un logorio psicofisico ed emotivo). Abbiamo anche utilizzato alcune parti delle rilevazioni OCSE-PISA per valutare gli indicatori qualitativi relativi ad apprendimento, benessere e malessere.
Ciò che volevamo ottenere era una stima della sensazione di inadeguatezza e disagio a scuola sperimentata dai giovani, identificando anche il limite significativo, cioè il discrimine fra un malessere risolvibile e uno talmente acuto da essere fonte di ansia, angoscia, preoccupazione, desiderio di fuga e percezione che ciò che lo studente sta vivendo è nocivo per lui.
Quando abbiamo cominciato ad analizzare i dati ci siamo agitati tutti. I numeri sono impressionanti: il 27% del campione italiano sta «così così» (non «bene»); il 73% sta male e all’interno di quest’ultimo gruppo il 60% sta male stabilmente. In altre parole, non ha ricordo di essere mai stato bene a scuola.
PERCHÉ I RAGAZZI STANNO MALE?
Dopo aver acquisito i risultati sulla presenza lampante di un malessere ci siamo chiesti perché stessero male, tutti questi ragazzi; così ci siamo dedicati ad analizzare gli indicatori qualitativi. È stato come ricevere un pugno allo stomaco: un indicatore qualitativo emerso massicciamente riguarda il carico richiesto ai ragazzi, ed è la prima volta che questo aspetto viene identificato nella scuola italiana. Siamo di fronte a un problema di inadeguatezza del carico cognitivo, per quantità e qualità: i nostri ragazzi vengono ingozzati (questa è la quantità) di prestazioni (questa è la qualità). Intendo dire che ai ragazzi viene chiesto di memorizzare procedure e regole in grande quantità anziché di far proprie delle conoscenze che servano loro per sviluppare delle competenze utili per il futuro.
Questa è una prima causa di malessere, ma non è l’unica a essere emersa. A livello emozionale abbiamo riconosciuto traiettorie emotive che sono collegate a emozioni di continuo alert. Questo stato di allerta costante dei ragazzi riguarda le verifiche, il giudizio, le scadenze che incalzano e il fatto di non essere in grado di dedicare tempo a ciò che appassiona.
Inoltre fra gli elementi determinanti si registrano due emozioni particolarmente disturbanti: la noia e il senso di colpa. Sono emozioni molto pesanti e si può dire che accompagnino la maggior parte degli apprendimenti scolastici: accade che uno studente, se non riesce, si senta colpevole oppure si annoi terribilmente, o le due cose insieme.
Dunque allo studente viene chiesto di imparare troppo, in poco tempo, senza passione, con l’ansia di doverne rendere conto, la frustrazione di non riuscire, la sensazione di perdere tempo per cose più utili e piacevoli: di fronte a tutto ciò il cervello, che è una struttura vivente che ogni millesimo di secondo resetta i propri circuiti sulla base delle informazioni che riceve, è costretto a spendere energie per qualcosa che non provoca benessere, bensì allerta.
Questo testo è tratto dal libro "Cinque lezioni leggere sull’emozione di apprendere" di Daniela Lucangeli.
Leggi di più
Una sfida educativa per la scuola italiana ai tempi della pandemia
La pandemia da Covid-19 e le conseguenti misure di lockdown, chiusura delle scuole, restrizioni e limitazioni hanno modificato in maniera significativa l’ambiente di vita e relazionale di bambini, bambine e adolescenti, e ciò ha avuto e continua ad avere un impatto sul loro benessere fisico e psicologico. Nell’ultimo anno e mezzo, la chiusura e poi l’intermittente riapertura e chiusura delle scuole, l’abolizione delle occasioni di socializzazione, la riduzione dell’attività fisica e l’alterata regolazione dei ritmi circadiani, la continua esposizione ad elevati livelli di stress e a situazioni di trauma collettivo hanno rappresentato, secondo il neuropsichiatra Stefano Vicari, delle minacce per la salute mentale di bambini, bambine ed adolescenti.
Lo psicoanalista dell’età evolutiva Massimo Ammaniti sottolinea che per bambini e bambine sono venuti a mancare “esperienze e stimoli sociali fondamentali: svegliarsi la mattina, prepararsi, essere accompagnati dai genitori, incontrare gli insegnanti e i coetanei. L’identità dei bambini è molto legata ai ritmi, alle abitudini, ai riti della vita quotidiana e ai suoi ambienti, per cui, venendo meno questi elementi, i rischi sono il disorientamento e l’insicurezza. Queste mancanze, insieme all’assenza di altri stimoli importanti (il confronto con altri bambini, i giochi di gruppo, le attività scolastiche), hanno creato una vera e propria sindrome di deprivazione sociale” . Anche per gli adolescenti si è creata una situazione estremamente complessa. Ammaniti sottolinea che “gli adolescenti vivono in un’area sociale importante di sperimentazione di rapporti con gli altri” e il loro cervello “è molto sensibile agli stimoli sociali; con la didattica a distanza e con tutte le restrizioni proprio il loro ambito di vita si è fortemente ridotto e questo ha pesato sulla loro identità e su questo periodo in cui hanno bisogno di sperimentazioni molto ampie”.
Per quanto riguarda l’impatto della pandemia sulla salute mentale di bambini, bambine ed adolescenti, uno studio preliminare condotto in Cina nel febbraio 2020 aveva evidenziato un aumento nei minori tra i 3 e i 18 anni di problemi comportamentali e psicologici come irritabilità, disattenzione, comportamenti dirompenti, disturbi del sonno, agitazione, ansia da separazione, paura, ansia e incertezza verso il futuro. In Italia, un’indagine sull’impatto psicologico della pandemia promossa dall’IRCCS Giannina Gaslini durante il lockdown della primavera del 2020 che ha coinvolto 3251 famiglie con bambini e adolescenti senza patologie neuropsichiatriche ha riscontrato disturbi e comportamenti disfunzionali simili a quelli rilevati nello studio cinese. L’indagine Gaslini ha registrato nel 65% di bambini e bambine al di sotto dei 6 anni un aumento di irritabilità, disturbi del sonno e disturbi d’ansia, nel 71% di bambini e bambine con più di 6 anni un aumento di regressione e una significativa alterazione del ritmo sonno/veglia, e negli adolescenti, maggiore instabilità emotiva con irritabilità e cambiamenti del tono dell’umore. La ricerca ha evidenziato inoltre che la gravità dei comportamenti disfunzionali dei minori era legata al grado di malessere con cui i genitori avevano vissuto il lockdown. Questo significa che all’aumentare nei genitori dei sintomi di stress causati dall’emergenza Covid-19 (disturbi d’ansia, dell’umore, del sonno, consumo di farmaci ansiolitici), aumentano i disturbi comportamentali e della sfera emotiva dei figli.
L’effetto negativo del lockdown è risultato più evidente in bambini e ragazzi con disturbi preesistenti alla pandemia come quelli inerenti all’attenzione e alla iperattività (ADHD), all’apprendimento (DSA) e allo spettro autistico (ASD).
Studi ed indagini più recenti confermano l’aggravarsi del malessere psico-emotivo e dei problemi di salute mentale dei minori. Continua ad aumentare lo stress degli italiani collegato alla pandemia e tra i più esposti ci sono i giovani, "nei quali si sta sviluppando un'onda lunga di problemi psicologici", mette in guardia il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP).
A sentirsi stressate a un livello medio-alto sono quasi 8 persone su 10, secondo un aggiornamento dello 'stressometro', l'indagine periodica realizzata dall'Istituto Piepoli proprio per il CNOP. L'indagine è stata condotta l'11 gennaio 2021 su un campione rappresentativo della popolazione. Il 23% riporta un basso livello di stress, il 43% un livello medio e il 34% alto. Tra i più esposti ci sono i giovani che vivono con criticità la perdita del punto di riferimento rappresentato dalla scuola.
Separati dai compagni e senza la scuola in presenza a fare da ammortizzatore di stress, disagi e disturbo mentale, e da luogo di socializzazione per la costruzione di relazioni positive in un contesto educativo, spesso i minori trascorrono le giornate a casa, a chattare, giocare ai videogames, guardare la televisione, ma anche solo a fissare il soffitto. Secondo Vicari, “quando sarà finita l’emergenza ci vorrà tempo prima che i ragazzi ristabiliscano rapporti sereni. Sarà difficile farli uscire da casa".
Vicari rileva che sono aumentati i problemi di sonno, l'ansia, l’irritabilità che in alcuni casi è sfociata in aggressività verso i genitori e se stessi. Bambini, bambine e ragazzi hanno cominciato a far male ai loro corpi per esprimere il loro disagio, la sofferenza, la paura. Tutti fenomeni che c'erano già, prima: tagli inferti a gambe e braccia, altre forme di autolesionismo, il rapporto malato con il cibo, l'anoressia, la bulimia, i suicidi o i tentativi di suicidio. Ma che sono aumentati, in alcune zone del Paese addirittura raddoppiati. Vicari rileva come siano aumentati notevolmente, da ottobre 2020, gli accessi in Pronto Soccorso per disturbi mentali, in particolare tentativi di suicidio o atti di autolesionismo. "Per settimane aggiunge - abbiamo avuto otto posti letto su otto occupati, e non era frequente, e tutti per tentativo di suicidio. Non mi era mai capitato". Secondo l'esperto, va considerato che l'onda lunga di questi disagi o disturbi nei ragazzi "ci accompagnerà anche finita l'emergenza", per cui è importante agire, "investendo sulla salute mentale" .
Se è indubbio che investimenti volti a rafforzare la rete dei servizi di salute mentale siano necessari, è importante ricordare che la scuola è una risorsa indispensabile per limitare il malessere e lo stress generato dalla pandemia. La scuola, per un bambino, non è soltanto un luogo per l’apprendimento di materie curricolari, ma, secondo Stefano Vicari e Silvia di Vara, “un’occasione unica per sperimentare relazioni, riconoscere negli altri le proprie emozioni, scoprire se stessi. Occorre recuperare questo aspetto che qualifica enormemente l’esperienza scolastica per alunni e insegnanti”. È cruciale quindi che bambini, bambine e adolescenti tornino a scuola, ma anche che la scuola cambi e diventi “più sicura, più accogliente, più inclusiva e soprattutto resiliente, in grado di far fronte alle crisi presenti e future. Un cambiamento atteso da tempo, che l’emergenza ha oggi reso necessario e non più procrastinabile”.
Questi temi verranno approfonditi al Convegno Internazionale di Erickson “La Qualità dell’inclusione scolastica e sociale”, che vedrà ospite alla Q Talk 1 del 12 novembre Stefano Vicari (Università Cattolica di Roma e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù), Massimo Ammaniti (Università di Roma La Sapienza), e Giacomo Stella (SOS Dislessia).
Bibliografia
Adalgisa Marrocco, La solitudine dei bambini ai tempi del Covid. Ammaniti: “Sindrome da deprivazione sociale”, Huffpost 16 dicembre 2020
Save The Children Italia, Benessere psicologico e Covid: le interviste a 4 esperti sul tema”, 26 luglio 2021
Jiao WY, Wang LN, Liu J, et al. Behavioral and Emotional Disorders in Children during the COVID-19 Epidemic. J Pediatr. 2020;221:264-266.e1. doi:10.1016/j.jpeds.2020.03.013
Luciana Gaita, Impatto psicologico del lockdown su bambini, studio del Gaslini: ‘Ansia e regressione per 6 minori su 10. Malessere legato a quello dei genitori’, Il Fatto Quotidiano, 16 giugno 2020
Merzon E, et al. ADHD as a risk factor for infection with Covid-19. J Atten Disord. 2020 Jul 22;1087054720943271. doi: 10.1177/1087054720943271. [5]Colizzi M, et al. Psychosocial and behavioral impact of COVID-19 in autism spectrum disorder: an online parent survey. Brain Sci. 2020, 10, 341; doi: 10.3390/brainsci10060341; Lima MES, et al. Could autism spectrum disorders be a risk factor for COVID-19?Med Hypothese. 2020 May 30; 144:109899. doi: 10.1016/j.mehy.2020.109899
Redazione Ansa, Generazione Covid, per i ragazzi alle prese con la pandemia è emergenza psicologica, 03 febbraio 2021
Annalisa Cuzzocrea, Covid e stress da isolamento di bambini e ragazzi: più soldi per potenziare la neuropsichiatria infantile, La Repubblica, 18 maggio 2021
Stefano Vicari & Silvia di Vara, Introduzione, “Bambini, adolescenti e Covid-19. L’impatto della pandemia dal punto di vista emotivo, psicologico e scolastico” Edizioni Centro Studi Erickson 2021
Save The Children, “La scuola che verrà. Attese, incertezze e sogni all’avvio del nuovo anno scolastico”, settembre 2020
Leggi di più