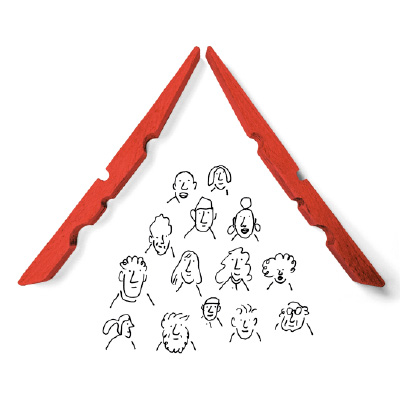Accedi/registrati
Entra nel
Mondo Erickson
Mondo Erickson
Entra In Erickson
Informazione obbligatoria
Non sei ancora un utente registrato? Registrati ora.
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e da
Privacy Policy e
Terms of Service di Google
I mini gialli dei dettati 2
Carrello
Spedizioni veloci
Pagamenti sicuri
Totale:
Il tuo carrello è vuoto
|***
Libro
Quantità:
Filtra per categorie
Tematica
Argomento
Utile in caso di
Filtra
Risultati trovati: 94
La creazione di un clima scolastico positivo è il presupposto per soddisfare i bisogni di alunne, alunni e insegnanti e promuovere lo sviluppo di competenze
La scuola è un ambiente in cui bambine, bambini e adolescenti possono da una parte sviluppare le competenze necessarie per affrontare le sfide sociali, lavorative, personali della vita fuori dalla scuola, e dall’altra soddisfare i bisogni di appartenenza, accudimento e riconoscimento del proprio valore. Ciò presuppone un clima scolastico positivo e la promozione del benessere socio-emotivo di insegnanti, bambine, bambini e adolescenti, entrambi presupposti necessari per l’apprendimento. Daniela Lucangeli sottolinea che ciò che impariamo si fissa nel cervello insieme alle emozioni: “se un bambino impara con curiosità e gioia, la lezione si inciderà nella memoria insieme alla curiosità e alla gioia. Se impara con noia, paura, ansia, si attiverà l’alert: la risposta della mente trasmetterà il messaggio «Scappa da qui, perché ti fa male».
Un clima scolastico positivo è una di quelle cose difficili da definire e misurare, ma tutti, genitori compresi, lo riconoscono quando lo vedono. Lo stato delle strutture scolastiche, il tono delle conversazioni nei corridoi, il modo in cui alunni e alunne interagiscono tra di loro, l'entusiasmo del personale scolastico sono alcuni dei segnali indicativi del clima scolastico. Il clima scolastico influenza il benessere socio-emotivo di alunni e alunni. Per misurare il clima scolastico e il benessere di studenti e studentesse, OCSE PISA usa indicatori che si riferiscono al contesto scolastico, in particolare il clima collaborativo: studenti e studentesse ottengono punteggi più alti in lettura quando c’è cooperazione tra compagni. In Italia, il 48% dei quindicenni ha riferito che i propri compagni di scuola collaborano tra di loro (media OCSE: 62%). Gli altri indicatori misurati da OCSE PISA includono: sentirsi solo/a a scuola (nel 2018 circa il 12% dei quindicenni italiani ha dichiarato di sentirsi solo a scuola), essere vittima di bullismo (in Italia il 24% dei quindicenni ha dichiarato di essere vittima di bullismo almeno qualche volta al mese), saltare giorni di scuola e arrivare in ritardo (il 21% ha saltato una giornata di scuola nelle due settimane precedenti PISA e il 48% è arrivato in ritardo).
OCSE PISA usa inoltre degli indicatori del benessere di studenti e studentesse, che non si riferiscono specificamente al contesto scolastico. Questi indicatori sono comunque rilevanti perché gli adolescenti trascorrono gran parte del loro tempo a scuola e i loro compagni e compagne giocano un ruolo preminente nella loro vita sociale. In Italia il 67% degli studenti e studentesse ha dichiarato nel 2018 di essere soddisfatto della propria vita e il 91% ha riferito di sentirsi felice qualche volta o sempre).
Nella maggior parte dei Paesi, i quindicenni sono più propensi a segnalare sentimenti positivi quando hanno dichiarato un più forte senso di appartenenza a scuola e una maggiore cooperazione.
In quasi tutti i sistemi educativi, anche in Italia, le ragazze hanno espresso unapaura di falliremaggiore rispetto ai ragazzi. Nella maggior parte dei sistemi scolastici, chi ha espresso una maggiore paura di fallire ha ottenuto punteggi più alti in lettura, ma ha riferito una minore soddisfazione per la vita, rispetto a chi ha espresso una minore preoccupazione di fallire. Infine, la maggior parte dei quindicenni dei Paesi OCSE ha una mentalità di crescita, cioè ritiene che le loro abilità e la loro intelligenza possa svilupparsi nel tempo (il 59% degli italiani; media OCSE 63%). Nei Paesi OCSE, la mentalità di crescita è stata associata positivamente alla motivazione ad affrontare compiti, all'autoefficacia, alla definizione di obiettivi di apprendimento e alla percezione del valore della scuola; è stata associata negativamente alla paura di fallire.
Il benessere degli insegnanti è sicuramente un fattore che influenza la loro soddisfazione lavorativa e l'entusiasmo per il loro lavoro. È correlato alla motivazione, ha un impatto i termini di qualità e rendimento, ed è un fattore chiave che influenza la motivazione e i risultati di studenti e studentesse.
I risultati PISA 2018 evidenziano che studenti e studentesse ottengono punteggi più alti in lettura quando percepiscono il loro insegnante come entusiasta e interessato alla materia. Circa il 74% degli studenti e studentesse italiane è d'accordo o molto d'accordo sul fatto che il loro insegnante mostri piacere nel fare lezione. Il benessere riguarda diversi aspetti della professione di insegnante: il carico di lavoro, le condizioni di lavoro, il senso di sicurezza, il supporto di colleghi, colleghe e dell’istituzione, gli aspetti relazionali con studenti e studentesse, con i genitori e altri soggetti coinvolti nella scuola e, naturalmente, l'apprezzamento della comunità più ampia. Se questi aspetti sono fonte di esperienze negative, l’insegnante può trovarsi in uno stato di esaurimento fisico ed emotivo, di stress e di burnout, e la loro salute mentale e fisica può risentirne. Diversi studi evidenziano lo stress come uno dei fattori che rendono particolarmente difficile la professione di insegnante. Un’analisi di Eurydice del 2021 rivela che in tutta Europa molti insegnanti soffrono di stress sul lavoro (in Italia circa il 35% degli insegnanti della scuola secondaria di I grado, contro una media UE del 47%). L'evidenza sembra indicare che i livelli di stress sono più bassi quando gli insegnanti lavorano in ambienti scolastici che percepiscono come collaborativi, quando si sentono sicuri di sé nel motivare gli studenti e nel gestire il loro comportamento e quando sentono di avere autonomia nel loro lavoro.
Non sono ancora disponibili i dati sull’impatto della pandemia e delle interruzioni scolastiche sul clima scolastico ed il benessere di insegnanti, studenti e studentesse. È ipotizzabile che abbia avuto un impatto negativo.
A Didattiche.2022 parleremo ampiamente di come creare un clima scolastico positivo e promuovere benessere a scuola.
Fonti
Lucangeli D., Cinque lezioni leggere sull’emozione di apprendere, Trento, Erickson, 2019
OECD, Pisa 2018 Results Combined Executive Summaries Volume I, II & III, OECD 2019
OECD PISA 2018 Nota Paese Italia
European Commission/EACEA/Eurydice, 2021. Teachers in Europe: Careers, Development and Well-being. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Leggi di più
Daniela Lucangeli approfondisce il tema della speranza dal punto di vista della psicologia spiegando quanto sia prezioso il suo ruolo, in particolare in questo periodo di pandemia
Durante l’autunno del 2020, mentre cercavo di fare un po’ di luce sulla «mente che sente» in relazione al periodo di pandemia, mi è arrivata una lettera meravigliosa da un signore di nome Giovanni, che mi ha spinta ad approfondire il tema della speranza.
«Cara Prof., io sono un anziano disabile, non mentale. Da sempre sono in carrozzina, anzi credo di essere nato con questo mio prolungamento. Non ho mai camminato. L’esperienza del camminare non ce l’ho, eppure io ho fatto tanta strada. Non ho avuto figli ma sono stato maestro per 35 anni e ho accompagnato ogni mio allievo a essere se stesso, a imparare a fare da solo. Oggi purtroppo, ahimè per età, sono solo un osservatore alla finestra. Vedo la vita passare, la vedo inciampare e la vedo perdersi. Allora io, cara Daniela, le regalo la mia analisi: il malessere, il dolore della mente di cui lei parla, io lo conosco bene. L’ho temuto, ne sono scappato tante volte, l’ho affrontato e riaffrontato, ho lottato e ho vinto. Sotto e ancora più sotto, alle fondamenta di questo dolore sta la mancanza di speranza. È lì che si deve cercare la causa del vuoto di luce che ci sta disorientando tutti. Accenda un po’ di consapevolezza nuova sulla speranza!»
Ho accolto volentieri l’invito accorato di Giovanni e ho cercato di indagare sull’argomento. Molte sapienze si sono occupate della spes, la parola latina per chiamare la speranza.
Nella ricerca scientifica non c’è, invece, una definizione univoca del concetto di speranza. C’è anzi una sorta di diatriba: che cos’è la speranza? Perché noi la proviamo? È un’emozione?
Diremmo che ci assomiglia, in effetti; eppure gli studi che se ne occupano da un punto di vista neurofisiologico dicono che non si tratta di una vera e propria emozione, perché non ha le caratteristiche tipiche di attivazione neurofisiologica.
Potremmo in un certo senso dire che i sentimenti (come l’amore o l’amicizia) indicano uno stato del sentire che si prolunga per tanto tempo nella nostra vita, mentre le emozioni uno stato del sentire istantaneo.
Potrebbe sembrare, allora, che la speranza sia un sentimento. Ma anche ammettendo che sia così, questa classificazione è davvero sufficiente?
Negli anni Novanta anche Charles Richard Snyder, esponente degli studi di Psicologia positiva, ha cercato (forse per primo) di fare un po’ di ordine negli studi sulla speranza, lavorando alla Theory of hope. Secondo questo ricercatore, la speranza appartiene al costrutto della motivazione, il che equivale a dire che la speranza è una molla che ci spinge ad agire, ma non come se noi fossimo passivi: ci attrae a sé in maniera proattiva. Secondo Snyder, le due qualità principali della speranza sono l’agentività (io sono agente della mia speranza) e il potere di procedere: io non soltanto agisco per raggiungere la speranza di qualcosa, ma so cambiare strada se vedo che mi sto allontanando dall’obiettivo, perché non posso perdere la speranza.
Dopo esserci domandati che cosa sia, dobbiamo chiederci: come ci fa sentire la speranza? Mary, una bambina di sette anni, risponde con queste parole: «Quando le speranze mi finiscono capita che piango di tristezza, ma quando ritornano capita che mi sento guarita». Noi, in sintesi, assumendo un punto di vista psiconeurobiologico, possiamo rispondere affermando che chi spera è più resistente alla frustrazione, è più resiliente, prova meno stress, ha maggiore flessibilità psichica e comportamentale, ha maggiore adattabilità, ha maggiori capacità prosociali ed è più facilmente benvoluto dagli altri, oltre a piacere a se stesso…
Leggi di più
Alcuni esperti di psicologia ed educazione, da Franco Lorenzoni a Daniele Novara, da Alberto Pellai a Giuliana Franchini a Giuseppe Maiolo, offrono suggerimenti e spunti di riflessione per affrontare il tema della guerra con i più piccoli
Dal 24 febbraio scorso, attraverso fotografie, video, servizi, la guerra è entrata nei discorsi quotidiani e nei pensieri di tutti noi. Così come è entrata negli occhi e nella mente di noi adulti, è entrata anche negli occhi e nella mente dei più piccoli, ossia di coloro che hanno meno strumenti, sia dal punto di vista cognitivo che da quello emotivo, per difendersi dal dolore e dalla devastazione che un evento tragico come la guerra provoca, anche quando non la si vive direttamente sulla propria pelle.
Siamo stati in tanti a chiederci fino a che punto sia giusto parlare di guerra con i bambini e soprattutto come farlo in modo corretto, evitando di spaventarli e turbarli ulteriormente e allo stesso tempo senza dare loro certezze che potrebbero rivelarsi false.
In questi giorni vari esperti di educazione, didattica e psicologia si sono espressi su questo argomento. Qui di seguito abbiamo raccolto alcuni dei loro interventi più significativi. Ve li proponiamo in sintesi.
Franco Lorenzoni: «È importantissimo parlare di guerra con i bambini, ascoltandoli e dando valore al loro pensiero”
Franco Lorenzoni, maestro elementare per quarant’anni e fondatore della Casa-laboratorio di Cenci ad Amelia, non ha dubbi: di guerra con i bambini è importantissimo parlare, perché i bambini «sono in grado di affrontare grandi temi a qualsiasi età». L’importante è “farlo insieme”, dandosi tempo, «ascoltarli con attenzione per poter affrontare le loro ansie e timori e per riuscire a dare valore al loro pensiero, dialogando con loro».
Il dialogo e il confronto sono ancora più importanti laddove c’è una paura da affrontare, continua il maestro Lorenzoni: «Proprio perché la guerra è una cosa che spaventa, che fa paura, bisogna cercare di elaborare insieme la paura. Non dimentichiamo mai che la guerra è il modo più osceno in cui si palesa ai loro occhi la follia del mondo adulto che, invece di rassicurarli, li terrorizza». Alla domanda su come rispondere agli interrogativi dei bambini sulla guerra, Lorenzoni suggerisce la strada della sincerità, anche ammettendo di non essere noi stessi in grado di capire certe cose: «Siamo tutti di fronte a qualcosa di difficilmente comprensibile perché anche noi adulti non sappiamo esattamente perché è scoppiata questa guerra e, soprattutto, come andrà a finire. Credo che confrontarsi con il tema dell'incertezza, ammettendo le nostre difficoltà, appartenga a pieno titolo all'educare alla complessità, oggi».
L’intervista completa di Franco Lorenzoni a “la Repubblica” è disponibile al seguente link.
Daniele Novara: «Parliamo di guerra ai bambini dai 9-10 anni, prima sono troppo piccoli, occorre proteggerli»
La pensa in maniera un po’ diversa da Lorenzoni il pedagogista Daniele Novara, che è anche fondatore del Centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti, secondo il quale è opportuno iniziare a parlare di guerra ai bambini nella seconda infanzia, a partire dal 9-10 anni: «Prima vanno in qualche modo protetti: la guerra è per fortuna qualcosa di distante dal loro immaginario e bisogna evitare di farla entrare nelle loro emozioni infantili. I bambini non andrebbero esposti alle immagini di distruzione e di morte. Ancor più se soli, abbandonati davanti alla tv senza filtri o protezioni».
Un errore importante da evitare di commettere secondo Novara è quello di paragonare i litigi dei bambini ai conflitti bellici: «Creare questa assurda correlazione tra il litigio infantile - un comportamento normale, innocente, naturale, legato al gioco - e un evento così tragico, devastante e irreversibile, come quello della guerra, è l'errore principale che possiamo fare: è terrorismo educativo. Piuttosto è imparando a litigare che si imparano a gestire i conflitti».
L’intervista completa a Daniele Novara si può leggere nell’articolo de “la Repubblica”
Alberto Pellai: «Anche nei giorni di tempesta noi adulti dobbiamo saper essere base sicura per i nostri bambini»
Alberto Pellai, medico psicoterapeuta, ricercatore e scrittore, sottolinea l’importanza di trasmettere un senso di vicinanza e sicurezza ai bambini: «Per i bambini vedere immagini di guerra è destabilizzante e traumatizzante. I piccoli vanno rassicurati e tranquillizzati perché non riescono a proteggersi da soli, sono completamente dipendenti dagli adulti che si occupano di loro. Bisogna mostrare loro un mondo che riesce ad accogliere i bambini in fuga dalla guerra, facendo vedere come in questa parte del mondo i bambini riescono a diventare anche salvatori di altri bambini».
Alberto Pellai suggerisce di far diventare la guerra una narrazione attraverso cui si costruisce la pace, perché l’unica educazione a cui hanno diritto i bambini è quella alla pace, come ci ricorda anche Gianni Rodari nella poesia “Promemoria” ( “Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra: per esempio, la guerra”).
L’intervista ad Alberto Pellai ripresa qui è stata rilasciata nella puntata del 5 marzo 2022 del programma “Le parole” di Massimo Gramellini su RAI3.
Giuliana Franchini: «Chiediamo ai bambini come si sentono e stimoliamoli a condividere con noi le loro ansie e le loro paure»
Giuliana Franchini, psicoterapeuta infantile, ha pubblicato un video assieme al marito Giuseppe Maiolo, psicoterapeuta a sua volta, per aiutare i genitori ad affrontare il tema della guerra in Ucraina insieme ai propri bambini, evitando di traumatizzarli (“Come raccontare la guerra in Ucraina ai bambini: il video”, pubblicato sul sito del Giornale di Brescia).
Secondo la psicoterapeuta, la cosa più importante da fare è non lasciare i bambini da soli a vedere le immagini di distruzioni, sparatorie ed esplosioni diffusi a profusione dai servizi di informazione. Questo perché fino agli 8 anni i bambini non hanno ancora elaborato bene il concetto di morte, perciò non sono in grado di affrontare questi argomenti senza un accompagnamento adeguato da parte degli adulti.
Un altro suggerimento della psicoterapeuta è quello di chiedere ai bambini come si sentono, soprattutto se sono taciturni. «Bisogna riuscire a rassicurarli senza appesantirli con i nostri pensieri e le nostre angosce di adulti. Risulta fondamentale accogliere le loro preoccupazioni e il loro dolore, aiutarli ad esprimere ansie e paure, che non sono emozioni negative da tenersi dentro e nascondere, ma sentimenti che vanno elaborati e trasformati».
Leggi di più
Potenziare l’abilità di gestire le proprie emozioni può essere una risorsa all’interno degli spazi di apprendimento?
Una nuova sfida per l’Educazione
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo da mesi ha creato un cambiamento significativo nel nostro stile di vita per il quale stiamo tutti facendo ancora fatica ad adattarci. Le limitazioni degli spazi fisici, le precauzioni da adottare nel quotidiano, la possibilità di avvicinarsi per lavorare in sicurezza o per il piacere di stare insieme, hanno portato ad un ripensamento del contatto con l’altro e in generale del concetto di libertà al quale eravamo abituati.
Riconfigurare le abitudini è in generale un lavoro impegnativo che richiede alla persona non solo uno sforzo pratico ma anche e soprattutto un’elaborazione interna delle proprie emozioni legate all’adattamento in un contesto diverso da quello precedente.
Ci troviamo attualmente di fronte ad un cambiamento ancora in corso: non c’è nulla di veramente definito, chiaro, sicuro e l’incertezza sul futuro suscita frustrazione, paura, rabbia e anche molta confusione. È evidente che in un tale contesto può diventare più complicata la gestione delle nuove generazioni all’interno della scuola e della famiglia. Le due agenzie educative per eccellenza sono chiamate oggi a rappresentare una guida per bambini e ragazzi in un momento dove i punti di riferimento sono instabili anche per gli adulti.
Inoltre, in un periodo storico dove la condivisione scuola-famiglia stava già attraversando una crisi, oggi più che mai abbiamo bisogno di impegnarci a risanare questa frattura.
Gli esperti dell’educazione ritengono che l’insegnamento dell’Educazione Emotiva nelle scuole possa rappresentare oggi un valido supporto alle famiglie e agli insegnanti nel loro compito educativo: il programma didattico ed il “programma di vita”. In questo particolare momento di instabilità emotiva, creare uno spazio dove si insegni a riconoscere e gestire le proprie emozioni può inoltre favorire negli alunni l’apprendimento, il quale sappiamo essere influenzato fortemente dal clima emotivo.
Nuovi aspetti da considerare
Il ritorno alle lezioni in presenza ha portato a riconsiderare nuove regole di convivenza all’interno della classe in un contesto mutato, con conseguenti preoccupazioni riguardo l’adattamento degli alunni e degli insegnanti.
Oltre alle limitazioni fisiche degli spazi, va considerato che gli alunni sono rientrati in aula con l’esperienza del lockdown che può averli influenzati in modo diverso e a seconda di come è stato vissuto anche nel nucleo familiare. Come sappiamo, moltissime famiglie sono state destabilizzate da una costellazione di preoccupazioni legate alla propria salute e quella delle persone vicine, da lutti e disagi economici. Le angosce sperimentate in casa, che in un primo momento poteva rappresentare un luogo sicuro e protetto, sono state inevitabilmente respirate da bambini e ragazzi che hanno affrontato varie difficoltà.
Gli alunni entrano così in aula con esperienze emotive del tutto personali che necessitano di interventi mirati e mediati da adulti competenti per poter essere espresse e comprese.
Non possiamo lasciarli soli nell’elaborazione dei propri vissuti, è necessario prevenire il rischio di amplificare la situazione in modo irrazionale o quello di fuggire dalle emozioni spiacevoli negando legittime paure e preoccupazioni.
L’insegnante ha una grossa responsabilità educativa, rappresenta per gli alunni un adulto di riferimento e ha bisogno di strumenti di lavoro per capire come contenere eventuali reazioni di ansia, panico e soprattutto come creare un clima emotivo che non influenzi negativamente ma favorisca l’apprendimento.
L’Educazione Emotiva nella Scuola: ieri ed oggi
L’Educazione Emotiva è un approccio educativo orientato a sviluppare e potenziare l’Intelligenza emotiva nei bambini e nei ragazzi.
Essere intelligenti emotivamente vuol dire saper gestire le emozioni spiacevoli che inevitabilmente ci troveremo ad affrontare nel corso della nostra vita. La capacità di riflettere sui propri stati d’animo, dare un significato all’esperienza emozionale che si sta vivendo e avere le abilità di attraversarla sostenendo le difficoltà sono tutti aspetti che rientrano nel set dell’intelligenza emotiva.
È ormai comprovata l’importanza di educare alla gestione delle proprie emozioni come fattore di promozione del benessere psicologico della persona. Da diversi anni l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha delineato delle linee guida dove vengono proposti interventi educativi rivolti ai bambini e agli adolescenti, finalizzati a promuovere specifiche abilità in ambito scolastico fra cui l’empatia e la gestione delle emozioni. Tali abilità denominate life skills si riferiscono alle competenze che permettono di assumere comportamenti positivi, trattare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana.
La ricerca ha dimostrato che includere nei programmi didattici attività che potenzino l’intelligenza emotiva negli alunni rappresenta un fattore di protezione contro le dipendenze patologiche e in generale contro il disagio psicologico (ansia, depressione, comportamenti disadattati).
Alla luce delle considerazioni sopra descritte, è facile ipotizzare come l’educazione emotiva possa rappresentare una risorsa e un valido supporto alla scuola dove oggi, forse più di ieri, la nostra generazione si trova ad affrontare una sfida senza precedenti.
Leggi di più
Sara Romanelli, antropologa e insegnante alla scuola primaria, autrice di “Laboratori dal mondo”, spiega il ruolo e l’utilità che può avere l’antropologia in classe, soprattutto per affrontare i problemi educativi che sorgono in presenza di culture diverse
Comprendere perché sia fondamentale che la disciplina antropologica entri sempre più nel ruolo di protagonista nel mondo della scuola e delle istituzioni che si occupano della gestione e dell’organizzazione del sistema educativo non risulta difficile, ai giorni nostri. Nei percorsi di studio che devono obbligatoriamente intraprendere i futuri insegnanti della scuola pubblica per accedere alla professione di docente sono stati stabiliti dal decreto del MIUR n.616 del 2017 precisi obiettivi formativi che devono diventare bagaglio culturale dei futuri insegnanti; sul totale dei 24 CFU che prevede il pacchetto di crediti universitari abilitante, lo studente deve acquisire un totale di 6 CFU riguardante l’area antropologica: i saperi di base dell’antropologia sono dunque diventati un requisito fondamentale per poter svolgere la professione di insegnante nella scuola pubblica.
È un traguardo molto importante per le scienze antropologiche, come ho affermato anche nella mia pubblicazione “Laboratori dal mondo". Percorsi di antropologia e attività per la promozione dell’interculturalità alla scuola primaria”, pubblicata da edizioni Centro Studi Erickson nel 2022. Chi invece non conosce in modo approfondito la disciplina, di cosa si occupa, quali sono i suoi settori di interesse e quali metodi vengono utilizzati dagli antropologi per svolgere le loro ricerche, penserà forse che sia inusuale che l’antropologia si occupi sempre più in questi decenni di scolarizzazione, di educazione, di forme e strategie di inculturazione e di sistemi scolastici.
Cosa hanno in comune l’antropologia e la pedagogia? Come lavora un antropologo all’interno di un determinato contesto scolastico? Quali sono i suoi oggetti di studio e quali metodi utilizza per le sue ricerche? Questi, a mio parere, sono quesiti fecondi di spunti e fondamentali per capire di cosa si occupa l’antropologia dell’educazione - questo sotto-settore disciplinare specifico - e quali siano i suoi ambiti di studio e di interesse.
L’antropologia e la pedagogia sono scienze sociali che hanno molto in comune. In questi decenni il termine “pedagogia” è stato oggetto di una profonda rivisitazione accademica, oggi di fatto si separa l’idea di “pedagogia” da quella più attuale di “scienze dell’educazione”, in quanto la prima viene intesa come una disciplina prettamente di tipo filosofico, mentre le “scienze dell’educazione” vengono considerate un insieme di saperi diversificati e con una diversa provenienza epistemologica, riguardanti tutti l’ambito educativo.
Se rifletto sulla mia esperienza professionale e la mia storia personale, posso affermare che il mio percorso sia rappresentativo della possibile e sempre più frequente coesistenza delle due discipline in un'unica prassi didattica, da applicare quotidianamente nel contesto scolastico.
Sono antropologa, ho iniziato la mia carriera di insegnante nella scuola pubblica quasi dieci anni fa, sono entrata nel mondo della scuola come docente supplente, alcuni anni dopo essermi laureata in Antropologia culturale ed etnologia all’Università degli studi di Bologna. Appena dopo la laurea mi sono resa conto di quanto fosse complesso per me, in quanto antropologa, trovare una occupazione stabile che riguardasse i miei studi e le mie competenze. Quando iniziai a lavorare nella scuola pubblica, come docente curricolare e di sostegno, ruoli che si sono alternati negli anni ma che sono quasi sempre stati spesi alla scuola primaria, mi sono accorta che svolgevo il mio lavoro di docente con uno sguardo diverso rispetto a quello di molti colleghi laureatisi in Scienze dell’educazione o in Scienze della formazione, percorsi accademici che potremmo definire più “classici” per poter lavorare nel mondo della scuola. Vivendo questo tipo di sistema scolastico dall’interno, mi sono accorta nel tempo di aver sempre osservato e lavorato insieme ai miei alunni da insegnante-antropologa, non mi sono mai sentita una maestra con un percorso accademico “standard”, eppure paradossalmente ho scoperto di essere in possesso di alcune competenze e capacità di cui altri colleghi, privi di formazione antropologica, sembravano carenti. Il discorso sull’applicazione di metodi e strategie di tipo antropologico rivolto al sistema di istruzione pubblico, e privato, formale o informale, è sempre più attuale, ricco di spunti interessanti, variegato nelle sue applicazioni e a mio parere molto proficuo per ridefinire e ripensare la scuola di oggi.
Gli interessi degli antropologi per i sistemi educativi, siano essi formali o informali, nascono intorno agli anni ‘60 negli Stati Uniti, anche se già da decenni molti antropologi, taluni molto conosciuti come Franz Boas, Margaret Mead o Ruth Benedict, per citarne solo alcuni, si erano già interessati ai modi di trasmissione culturale nelle loro ricerche presso popolazioni viventi in società non occidentali o extra-europee. L’interesse per la dimensione culturale e sociale dell’istituzione scolastica e per il ruolo che al suo interno rivestono i diversi attori sociali - su tale definizione consiglio la lettura di un saggio di Erving Goffman, “La vita quotidiana come rappresentazione”, ricco di riflessioni e teorie sull’agire sociale, attori quali sono studenti, insegnanti, famiglie e istituzioni esterne che collaborano con le scuole, può generare una riflessione interessante su quanto le differenze culturali, religiose, etniche o linguistiche presenti oggi nel mondo della scuola possano portare, se affrontate con strategie didattiche appropriate a esiti educativi positivi, ad una maggiore interazione e integrazione nel gruppo classe e tra gli studenti, o ad una relazione positiva tra studenti e insegnanti, o al contrario generare, se trascurate o non risolte, incomprensioni, silenzi, possibili conflitti.
Lo studio dei processi di inculturazione – studi cari alle scienze antropologiche e all’antropologia dell’educazione, anche se attualmente meno in voga come terminologia rispetto a qualche decennio fa - rappresenta una modalità di riflessione sul come l’educazione “informale”, quella che si verifica fuori dal contesto scolastico istituzionale, riesca a plasmare la mente e l’operato dei bambini e dei ragazzi per trasformarli in portatori di una certa cultura, e permettere dunque l’esistenza e la trasmissione di determinati sistemi culturali (Spindler, 1974). Ciò che si verifica nel contesto extrascolastico genera in taluni casi una discontinuità culturale che può, nel momento in cui si incontra o si scontra, con modelli educativi diversi, generare incomprensioni e conflitti tra alunni e insegnanti, tra famiglia e insegnante, tra alunni nei confronti di altri alunni.
Per questo motivo è fondamentale comprendere quali sono i valori e i sistemi culturali di cui i nostri alunni sono portatori e per noi educatori-docenti, fare una riflessione su noi stessi e sui nostri valori, che non sempre corrispondono a ciò che la maggioranza definisce “la cultura ufficiale” - quella della maggioranza - di un determinato Paese.
Purtroppo, esiti di tipo negativo di questa discontinuità culturale e educativa vissuta talvolta dai ragazzi, sfociano nel fenomeno dell’abbandono scolastico da parte di molti alunni stranieri, che in Italia assume dimensioni preoccupanti. Nel nostro Paese, il numero di ragazzi che non raggiungono il diploma di scuola secondaria di secondo grado o sono impegnati in altre attività di formazione o di lavoro, sono in numero più alto rispetto ai dati della media europea. Nel 2022, l’11,5 dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni è uscito senza diploma dal sistema di istruzione (dati ISTAT, GOAL 4 Istruzione di qualità per tutti, Istat.it)
Un approccio etnografico al mondo della scuola permetterebbe di mettere in evidenza quindi quel mondo “sotterraneo” e “Altro” – inteso come “diverso” - rispetto alla percezione che gli stessi insegnanti e studenti hanno dell’istituzione scolastica, del loro ruolo e del loro agire all’interno di tale istituzione; utilizzando le tecniche di indagine tipiche dell’etnografia come le interviste agli studenti e gli insegnanti, l’osservazione sistematica del contesto di interesse, che ad esempio potrebbe essere una classe di una scuola primaria, le registrazioni video e audio della quotidianità a scuola, l’uso di materiale fotografico e degli appunti presi sul campo di ricerca, si possono portare in superficie vissuti, valori e dinamiche implicite che spesso vengono ignorate, o addirittura negate dalle stesse persone coinvolte nella ricerca.
Questo specifico ambito dell’antropologia dell’educazione viene nominato in ambito anglosassone “schooling”, il fare etnografia della scuola. Lo “schooling” permette di evidenziare le diverse pratiche culturali – esplicite e implicite -, analizzare i processi educativi e le relazioni che esistono tra le persone coinvolte, studiare i metodi di trasmissione culturale e ciò di cui sono portatori, spesso in modo inconsapevole. Uno studio etnografico del contesto educativo, sia esso scolastico o informale, può apportare un notevole contributo allo studio dei problemi educativi generati dalla presenza di individui e gruppi provenienti da culture diverse rispetto al contesto di migrazione.
Bibliografia
Dei F., Cultura, scuola, educazione: la prospettiva antropologica, Pisa, edizioni Pacini, 2018; Favaro G. Luatti L., L’intercultura dalla A alla Z, Milano, edizioni FrancoAngeli, 2004
Goffman, E., La vita quotidiana come rappresentazione, Bologna, edizioni il Mulino, 1969
Romanelli S., Laboratori dal mondo. Percorsi di antropologia e attività per la promozione dell’interculturalità alla scuola primaria, Trento, edizioni Centro Studi Erickson, 2022;
Tassan M., Antropologia per insegnare, Bologna, edizioni Zanichelli, 2020
@media (max-width: 576px){
.me-text ul li {
font-size: 19px !important;
line-height: 28px !important;
}
.me-text ol li {
font-size: 19px !important;
line-height: 28px !important;
}
}
.me-text ul li {
font-size: 22px;
line-height: 34px;
}
.me-text ol li {
font-size: 22px;
line-height: 34px;
}
Leggi di più
Letture consigliate a bambini, ragazzi e adulti per conoscere meglio il web e renderlo un posto più sicuro
Il secondo giorno della seconda settimana di febbraio, ogni anno, ricorre il “Safer Internet Day”: una giornata che ha l’obiettivo di promuovere un utilizzo più sicuro e consapevole del web, incoraggiando, in maniera particolare, i giovani di tutto il mondo ad avere un ruolo attivo e responsabile per fare di Internet un posto sicuro e positivo.
Quest’anno il “Safer Internet Day” cade il 7 febbraio. In occasione di questa giornata, diamo il nostro contributo all’impegno per una rete più sicura con una selezione di libri dal nostro catalogo: letture rivolte sia ai ragazzi che agli adulti, che possono aiutare a comprendere meglio i meccanismi della Rete e sensibilizzare tutti per un utilizzo del web più consapevole e positivo.
Scopri i titoli consigliati:
.image-carousel-container{ width:60%;}
.mondo-erickson .banner-container [class^='banner-lev'] {
position: relative;
width: 60%;
}
@media (max-width:767px){
.image-carousel-container{ width:100% !important;}
.mondo-erickson .banner-container [class^='banner-lev'] {
position: relative;
width: 100%;
}
}
Leggi di più