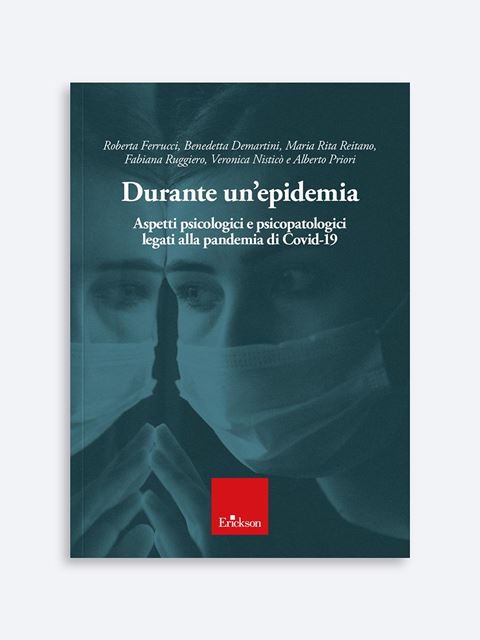Oltre che al dolore, al senso di smarrimento, all’ineluttabilità della morte, il periodo pandemico Covid 19 ci induce a riflettere anche su due aspetti apparentemente astratti ma, invece, molto comuni, che sono l’ “assenza”, intesa come presenza che non c’è in un ambiente che la identifica e la “mancanza”, come realtà emozionale scomparsa ma che rimane, inconscia, quale “traccia” di un’esperienza vissuta.
Iniziamo dall’assenza
Il periodo pandemico ne ha prodotta tanta; già i confini fisici di libertà entro i quali non abbiamo vissuto potrebbero da soli descrivere l’enormità del danno ma, ad essi, per una stima intera, dobbiamo aggiungere ogni sguardo che non abbiamo condiviso, ogni parola che non abbiamo detta e ogni abbraccio che non ci siamo dati; la vita è corrispondenza di sé con l’altro e per tale ragione la loro assenza è stata di fatto una limitazione all’esistenza stessa che, sappiamo, non si accontenta della pochezza di sé. Essa, la vita, è piena quando soddisfa ogni necessaria reciprocità, quando gode e alimenta la propria urgenza di essere con un’altra identità convergente e, ineluttabilmente, esterna a sé. Non si può essere senza esistere ma il rischio di esistere senza essere è in agguato almeno quanto quello di morire ogni giorno della solita vita. L’isolamento forzato al quale ci costringe una malattia, una disabilità o una reclusione coatta ne sono una testimonianza efficace. In queste dimensioni di separazione, infatti, l’assenza di una prospettiva di complementarità e dell’ipotesi grammaticale del futuro, chiude il naturale bisogno dell’essere e del divenire in quella stessa profondità che sopporta chi esiste, di fatto, senza saperlo, poiché non esiste il desiderio naturale di singolarità; esso non si addice alla vita. E se tale infelice disposizione è nulla gravosa in chi ha mai o poco conosciuto, per sua avversità, la reciprocità e l’incontro, lo è, invece, in chi ha goduto e vissuto nella relazione con l’altro. E ciò al quale ci riferiamo non è la relazione quale costrutto di abilità sociali erette e giustificate “situazionisticamente”, come opportuna invenzione della civiltà ma, piuttosto, come primario desiderio e necessità di scambio e assunzione della diversità che ci descrive, formando la nostra unicità. Non, quindi, la relazione volta all’interesse bensì l’interesse volto alla relazione, alla costruzione e alla ricerca continua di ciò che manca di sé.
Le assenze che ci hanno accompagnato in questo periodo pandemico hanno impersonato, principalmente per i bambini, l’inevitabile privazione di tutto ciò.
La mancanza
La mancanza è quel che resta di ciò che non c’è più. Essa si affida al ricordo da cui origina, all’esperienza che l’ha generata, e vaga dentro di noi come un’aria invisibile quando qualcosa o qualcuno non è presente nel luogo in cui vorremmo fosse o quando vorremmo noi stessi essere in una condizione che non c’è più.
La mancanza non è la nostalgia; da essa si differenzia per il fatto che mentre la nostalgia ha implicito un sentimento di rimpianto e ch’io desideri rivivere una certa cosa ormai lontana, la mancanza ha in sé e in aggiunta il timore, rassegnato, che quella cosa non torni mai più.
Tutti noi abbiamo sostenuto esperienze che ci hanno lasciato la traccia offuscata di una mancanza; ed è nell’esperienza di ognuno riconoscere che la sua sostanza è tanto più intensa quanto più felice è stata l’esperienza vissuta.
La scuola, primis, è una di queste esperienze e non dobbiamo permettere che di essa si generi una mancanza ancor prima di averla vissuta.
Il timore che ciò che stiamo abbandonando per via del Covid 19 si trasformi in una vera e propria mancanza è dunque alle porte.
Una formazione inaspettata
La pandemia, i confinamenti, possono fare scoprire che l’assenza è piena di tracce. E che la formazione può fare un salto di qualità se ridimensiona la cattedra da cui parlare per insegnare e invece impara a seguire le tracce. "[...] cominciai a capire che non si parla solamente per parlare, per dire ‘ho fatto questo’ ‘ho fatto quello’ ‘ho mangiato ho bevuto’, ma si parla per farsi un'idea, per capire come va questo mondo [...]"(C. Pavese, 1950; ediz. 1969, p. 92).
Nel corso dei tempi storici – quindi nella storia che noi possiamo conoscere – abbiamo avuto, nei confronti di chi viveva condizioni particolari, talune forme di esclusione che forzavano la loro assenza e che oggi riteniamo inaccettabili, tanto da aver proceduto nel tempo a una loro eliminazione così completa come è stato. Non lo si crederebbe, ma basta pensare ai sordi: il soggetto sordo – in un passato non così remoto al punto da non lasciare tracce, poiché non si colloca nella preistoria, bensì in una realtà con caratteristiche molto simili a quella che stiamo vivendo in Europa – era escluso, quasi irraggiungibile nella sua identità di “persona”; e in questo vi era l’implicita idea che la possibilità di educabilità del sordo fosse eresia; quasi una sorta di correzione della volontà del Creatore: sembrava una bestemmia.
Un’altra categoria di esclusi, condannati all’esistere senza essere, erano quelli ritenuti privi di intelligenza. Occorre aggregare in questa categoria, molto affollata, anche coloro che erano stati abbandonati e relegati in Istituti la cui prerogativa professionale era unicamente di provvedere alla salvaguardia dell’integrità fisica, senza perseguire alcuna forma educativa capace di formare l’intelligenza. Si parlava di idioti riferendosi a coloro che erano talmente diversi dagli altri da avere un’identità non comune. La parola ‘idiota’ non è considerata un insulto: è una parola di etimologia greca che vuol dire appunto questo.
Quando qualche ricercatore comincia a cercare di capire le differenze tra il “mucchio” di idioti nascono delle indicazioni che permettono di avviarne - con una progressione all’inizio molto lenta e poi più rapida – l’educabilità. Il riferimento più noto è quello del Dott. Down che permette di individuare tra gli idioti quelli che poi vengono chiamati soggetti con Sindrome di Down – dal nome dello stesso Dottore, il quale, per la verità, li chiamò “mongoloidi”, termine non più utilizzato.
Successivamente molto tempo dopo un altro esempio importante è quello dei soggetti con spettro autistico. Quando Leo Kanner individua le caratteristiche di quello che chiama – siamo nel 1943 – “autismo infantile”, fa un’operazione che permette di individuare caratteristiche che distinguono coloro che hanno lo spettro autistico dall’insufficienza mentale. Negli stessi anni Hans Asperger pediatra viennese, compie un’analoga operazione e individua un tipo di autismo – quello che oggi chiamiamo autismo, o sindrome, di Asperger – che è molto differente perché in esso è percepibile un’acuta intelligenza non applicata però alla realtà.
Ma non entriamo nei dettagli.
Ci interessa solo capire che le caratteristiche dell’esclusione nell’ineducabilità, da queste poche note storiche, sono la confusione, ovvero il confondere soggetti che hanno caratteristiche solo molto da lontano simili, ma in realtà assai diverse; il pregiudizio, ovvero la possibilità che vi sia un giudizio a priori che preclude ogni possibilità di avvicinare all’educazione soggetti “diversi” come il sordo di cui sopra, la mancanza di strumenti tecnici per individuarne le caratteristiche, l’assenza di comunicazione. Ancora un’assenza!
Da questo possiamo capire che l’educabilità e l’inclusione sono un processo, un passaggio – non quindi un dato già acquisito – che possiamo anche cercare di ottenere con un’azione che contenga elementi legati alla possibilità di una migliore conoscenza del soggetto sottratto alla confusione del mucchio, a migliori strumenti, a un quadro scientifico avvicinabile a tutti, e quindi volgarizzabile, a un clima culturale e sociale che permetta questo e a un’offerta formativa adeguata. Questi elementi, intrecciandosi, contribuiscono a passare dall’esclusione dell’ineducabilità all’inclusione dell’educabilità.
Esprimiamo alcune riflessioni sugli aspetti storici. Oltre all’esclusione dovuta al pretesto, avvolto in gergo scientifico, dell’ineducabilità vi è stata – ed è una pagina molto cupa della nostra storia – l’esclusione della dinamica dell’umanizzazione, privilegiando quella della disumanizzazione. Ci riferiamo soprattutto alla pagina nera del nazismo e del progetto di estinzione delle vite inutili: casi psichiatrici e bambini malformati – si diceva allora – espressione che comprendeva bambini ben formati ma con scarsa intelligenza e con scarsa possibilità di comunicazione. Questi soggetti dovevano essere uccisi. L’assassinio di massa caratterizza un processo di disumanizzazione il cui presupposto è quello che sono considerate bocche inutili, vite inutili, non avendo caratteristiche umane.
È una vicenda per certi versi diversa dall’esclusione e dell’ineducabilità ma nello stesso tempo ha collegamenti profondi. Il processo avviato dal nazismo non ha avuto reazioni di scandalo e tutto sommato ha trovato una buona partecipazione, per esempio, da parte dei professionisti: quando le cliniche pediatriche dovevano avviare verso la morte i bambini detti “malformati” e gli psichiatri dovevano avviare verso la morte i casi psichiatrici, essi non hanno reagito protestando e cercando di far sapere questa morte di massa. Le notizie sono trapelate in maniera diversa.
Un personaggio importante ma non molto conosciuto se non per certi momenti di fortuna spettacolare – Gerstein , un soggetto che ebbe in famiglia un congiunto che aveva dei problemi psichiatrici e per questo fu avviato verso le camere a gas – ebbe l’idea di penetrare nel mondo delle SS e di venire a conoscere più da vicino le vicende che stavano svolgendosi. Gerstein è un esempio interessante – lo diciamo, naturalmente, col senno di poi – di ricerca-azione, cioè di coinvolgimento in una ricerca, in questo caso su un tema sconvolgente, senza avere preordinato la possibilità di uscirne per testimoniare e rielaborane la realtà.
Kurt Gerstein ne fu travolto; alla fine della guerra, finì in prigione così come capitava a tutti coloro che appartenevano alle SS. In prigione proclamò la sua testimonianza, cercò di spiegare quali erano state le sue intenzioni. L’operazione però non andò a buon fine e Gerstein ufficialmente si suicidò. Vi sono molti sospetti su questo suicidio giacché Gerstein aveva tentato più volte durante la sua operazione di coinvolgimento di mettersi in contatto con corpi diplomatici di vari paesi, compreso il Vaticano, e da tutti era stato rifiutato pur sapendo che cosa egli volesse, anzi forse proprio perché sapevano che cosa avrebbe detto. In sostanza, dunque era un testimone scomodo.
E il suo suicidio ufficiale forse non corrisponde a quello che davvero accadde.
La formazione non formale
Abbiamo l’idea della formazione molto formale: un orario, dei formatori, un’iscrizione, eccetera. Questa idea di formazione rischia di non farci cogliere la formazione inaspettata. Come quella che abbiamo avuto da Didi. Una badante. Telefonare a Teresa voleva dire incrociare o direttamente o indirettamente Didi. Le era accanto. Se ne prendeva cura non trascurando i propri interessi culturali, dalla pittura all’architettura, oltre che il perfezionamento dell’italiano.
Ogni telefonata era una formazione a distanza. A posteriori, cerchiamo di mettere in un ordine quelli che possono essere i temi di questa formazione. Anche se uno degli elementi della qualità di questa formazione inaspettata è l’amalgama, l’intreccio. Cambiamo parola. Non temi ma ingredienti, come per un buon piatto di alta cucina. Gustandolo non individui tutti gli ingredienti, e forse quello che ti sfugge è il segreto della bontà del piatto.
Un ingrediente di base: i modi. Garbati e mai servili. Capaci di stare accanto, né sotto né sopra. Di prendere in considerazione il carattere a volte non facile di Teresa ma senza esagerare: il giusto. Ognuno ha il suo carattere e bisogna tenerne conto. Ma senza farne l’elemento protagonista assoluto del rapporto d’aiuto. Ancora facendo ricorso alla cucina, sarebbe mascherare l’insipienza di un piatto con una salsa aggressiva e prepotente. Dopo aver mangiato non sapremo dire cosa abbiamo ingoiato se non la salsa. Una buona formazione non è una somma di informazioni. È la contaminazione di uno stile discreto e nello stesso tempo attento, vicino e nello stesso tempo rispettoso delle giuste distanze. Una formazione sviluppata senza una cattedra e con l’autorevolezza di chi la sviluppa vivendola.
Un ingrediente importante è quella capacità di vivere i propri compiti con convinzione. Non troviamo una parola che da sola indichi questo ingrediente. È costituito da assenze e presenze. Sono assenti i sensi di frustrazione per l’impossibilità di fare carriera; le invidie per chi fa carriera; gli esibizionismi che sarebbero utili per fare carriera. È assente la carriera. È presente la consapevolezza che quello che fa, per umile che sia, è importante. E questa consapevolezza dà la forza e la possibilità di stare al proprio posto sentendosi alla pari con chi entra in contatto con Teresa, e inevitabilmente con lei, Didi.
Non è una protesi. Teresa non può servirsene come se lei, Didi, non avesse opinioni, convinzioni, idee. Sa farsi valere e nello stesso tempo lascia spazio alle scelte di Teresa. Anche in questo vediamo un ingrediente che non sembra sia possibile indicare con una sola parola. C’è flessibilità insieme a fermezza. Didi fa un lavoro che può creare confusione perché è svolto in una casa in cui anche lei vive, in una situazione di ambiguità fra l’essere ospitata ed essere colei che organizza l’ospitalità di chi la ospita. Una condizione che potrebbe creare un nodo scorsoio in cui rimanere intrappolati. Didi ha la vista lunga. Chi ha la vista corta vede bruchi, chi ha la vista lunga vede farfalle. Didi è intelligente e non usa furbizie: l’intelligente guarda a lungo termine il furbo a breve. Il tempo dettato dall’ascolto di chi abbiamo di fronte lascia tempo all’altro di esprimersi e di farsi conoscere. Il bisogno di stima dell’altro costruisce la nostra autostima rafforzandola.
La formazione a distanza che abbiamo ricevuto da Didi svela un argomento che tante formazioni, in presenza, danno per scontato; o meglio: utilizzano implicitamente. La casa. È un argomento che può rivelarsi fondamentale. Qual è la casa di Didi? Quella in cui lavora. Non può lavorare e poi andare a casa. In molte attività di formazione, chi forma può tranquillamente pretendere che chi è formato vada a casa, a studiare. L’idea di spazi distinti e destinati è ritenuta naturale, tanto che può essere implicita, ritenuta scontata. Non così per la formazione che riceviamo da Didi. La quotidianità intreccia spazi. Nella quotidianità di oggi viviamo i ricordi della quotidianità delle nostre infanzie. Nella casa dell’odierna quotidianità viviamo la casa di quando eravamo piccoli.
La formazione a distanza che riceviamo da Didi porta a fare coabitare in una certa armonia le diverse identità che abitano in noi. Sono diverse fra loro. Alcune sono le identità che non abbiamo e che vorremmo avere. Ci possono indurre a trattare dall’alto in basso qualcuno, e servilmente qualche altro, secondo la scala gerarchica su cui vorrebbe arrampicarsi la nostra aspirazione identitaria. La formazione offerta da Didi porta lontano dalle logiche di potere. Trasforma potere in possibilità. Potere rende schiavi e imprigiona in ricchezze, soldi, comodità, carriera, eccetera. Possibilità apre. Fa vacillare cliché e pregiudizi, stereotipi e luoghi comuni. Cambia l’ordine delle parole: le buone maniere diventano le maniere buone, che è tutta un’altra faccenda.
La formazione che Didi ci offre è all’insegna della semplicità e della semplificazione. Per questo è un’occasione inaspettata. Ci aspettiamo che una formazione sia complicazione: aggiunta di tante cose che ci fanno sentire prima dei poveracci e poi degli ex poveracci arricchiti. La formazione di Didi può conciliarci con noi stessi, e arricchirci di quello che siamo. La formazione non è avvenuta e avviene perché qualcuno chiede formazione, ma perché qualcuno contattava e ricorda Teresa e inevitabilmente, in maniera esplicita o in forma implicita, intercettava e intercetta Didi. Da quel momento comincia una formazione inaspettata e capace di accogliere senza sottoporre a test selettivi.
A volte buttiamo via le competenze della quotidianità, in nome della scientificità. Che non è un optional. Ma neppure un idolo a cui sacrificare quelle competenze. È una dimensione etica. Permette di confrontare e cambiare, correggersi. Di avere dei parametri e non degli atti di fede cieca. Aiuta a produrre argomentazioni documentabili e non appelli alla fiducia. Richiede l’etica della competenza. E non la vocazione che vuol far colpo per sedurre. Lavora sui propri limiti, e non sulla propria presunzione di infallibilità. Cambia direzione, se necessario, dicendo perché. Non spreca ma utilizza, creando nuove pietanze. Vive e non replica. Non vuole avere ragione ad ogni costo, ma sa prendersi un po’ in giro non presumendo di sapere tutto.
La passione di Didi per l’arte suggerisce un ulteriore ingrediente della formazione: il senso dell’eleganza. Che vuol dire senso della misura, capacità di fare accostamenti giusti, toni adeguati, curiosità rispettose, l’attenzione ai particolari… senza esagerare. Questo ingrediente porta nella nostra formazione il gusto dell’incompiuto che può trasformarsi in formazione continua, gusto dei lavori in corso. Attenzione: un cantiere di lavori che non finiscono mai può essere tale nel segno dell’abbandono che fa di quel posto una discarica. La formazione di Didi impegna tutti i giorni senza alcun abbandono. È la fedeltà all’impegno quotidiano, vissuta e proposta da questa formazione come un valore che non è mai concluso. Se fosse concluso svanirebbe. È come la fiducia: più ne dai e più ne avrai. Non è un gioco d’azzardo. È un lievito.
Ci potremmo domandare se tutto questo è il risultato di un caso fortunato. Domanda che permette di individuare due altri ingredienti: pazienza e discernimento. La pazienza di raccogliere le giornate una ad una, perché non ce n’è una che valga meno dell’altra. La parola pazienza ha una radice comune con patire. Non è casuale. È un’indicazione che può portare a dare un senso al patire, alla sofferenza. Le due parole, discernimento e pazienza, hanno un collegamento che testimonia la singolarità dell’essere vivente che solitamente ed imprecisamente chiamiamo, che sia maschio o femmina, uomo. La cura paziente coinvolge le mani. Che sono convocate quotidianamente per svolgere diversi compiti. Diversi come? Con discernimento. Le mani possono inchiodare a un destino: le impronte digitali come segno di un percorso già segnato, da cui non ti libererai. Le mani aprono, stringono. Modellano figure, oggetti possibili all’infinito. Se stringono, sanno anche allentare, alleggerire. Sanno stringere un’amicizia. E sanno allentare la morsa della sofferenza, del fallimento.
In ogni oggetto c’è il lavoro delle mani che modellano, che forgiano e che scoprono nuove forme. E forse mani che non si offrono facilmente perché non sanno ancora se saranno utilizzate per l’impronta digitale che ti chiude nel tuo essere zingaro, o moldavo, o tunisino … Hanno bisogno di incontrare una materia da modellare, faticosa e docile nello stesso tempo, capace di trasformarsi e diventare simbolo di un cambiamento possibile e oggetto mediatore per incontrare altri vivendo la possibilità del cambiamento. Oggetti – mediatori – che sapranno ambientarsi nel gusto di chi li prenderà. E che entreranno in case, in uffici, in vite diverse. Potranno, se vorremo e ne saremo capaci, diventare come i sassolini della fiaba, che permettono di ritrovare le tracce e così tornare a casa, cioè in un luogo sicuro.
Tante volte vediamo negli altri la nostra insicurezza. Sembra che ci minaccino. Ma le stesse mani hanno modellato oggetti che possono portare a vedere l’altro con occhi fiduciosi. Mani che afferrano per soccorrere. Mani che accarezzano per consolare. Sono nelle tue mani. Aiutami. Chiedo la mano di tua sorella, perché le voglio bene. Mani che modellano. E volevamo usare le mani per inchiodare al destino delle impronte digitali, che nella nostra fantasia portano alla scoperta del colpevole.
Attenzione: c’è anche il pilatesco lavarsene le mani, girarsi dall’altra parte o giustificare le nostre non risposte con le ragioni di chi sa che la mano che chiede può essere la mano che ruba. Meglio fare come Pilato. Una mano di bianco. E Barabba andrà libero mentre Cristo sarà inchiodato sulla croce.
Ma qui è più semplice. Basta guardare un oggetto, e vedervi il segno di mani. Che forse hanno afferrato un filo di speranza, arrivando nel nostro Paese. Mani che lavorano.
Mani da stringere. Per fare amicizia.
Sarà nelle mani ritrovate che incontreremo, che sparirà l’assenza oltre che la mancanza di noi e di ciò che avremmo potuto essere.
Una pedagogia equilibrista
Gardner (2005) afferma che “un esperto è una persona che è sempre in grado di rappresentare la conoscenza in più di un modo”, che è come dire che lo stesso esperto dispone di una grande flessibilità nell’affrontare i problemi e adattare le conoscenze acquisite per renderle esplicite. Questa flessibilità di rappresentazione implica, a sua volta, che l’esperto si affidi inevitabilmente all’azione. Rappresentare, infatti, significa proporre qualcosa attraverso un comportamento; il passaggio del suo sapere non prescinde da esso. Ma, nell’azione sta anche la comprensione: dire o fare qualcosa ne è la dimostrazione; non posso, infatti, dare prova pubblica di ciò che non so o che non mi appartiene. In altre parole, non solo il suo corpo di esperto rappresenta, ma anche quello del discente al quale egli descrive il suo sapere. In questa dinamica di co-rappresentazione la flessibile disponibilità che gli appartiene lo porterà a cogliere ogni sfumatura riflessa del suo sapere rappresentato nell’esecuzione dei suoi discenti. Sarà il corpo dell’altro, attraverso l’azione, a dirmi quanto sono stato chiaro ed esaustivo.
Arjun Appadurai (2021) , antropologo indiano alla New York University, rileva che ogni oggetto di consumo si e ci colloca in un contesto sociale e culturale diverso. Un essere umano che frequenta l’università consuma un corso di laurea. Se quell’essere umano avesse una disabilità, potrebbe trovarsi improvvisamente e quotidianamente in un forte contrasto fra un contesto protettivo e un contesto che pretende sia in grado di autodeterminare le proprie scelte. E di sviluppare capacità di autovalutazione che implicano capacità di aggiustamento correttivo. La sua flessibilità deve permettergli di conciliarla col contesto accademico e dei docenti in particolar modo.
Immaginiamo la rappresentazione del tempo e delle sue qualità tramite i colori. Immaginiamo ora la nascita di un bambino o di una bambina con esigenze particolari causate da un deficit. È quasi impossibile concepire in che modo cambierà la vita di una famiglia o di una persona in seguito al verificarsi di un simile evento inatteso e nei confronti del quale non si ha nessuna risorsa e nessuna preparazione adeguata. È una situazione in grado di trasformare la vita da una combinazione di colori, da una policromia fatta di tante sfumature diverse capaci di combinarsi più o meno armoniosamente, in una vita fatta di un solo colore. E questa situazione monocromatica sarà tanto più evidente quanto più la situazione di disabilità sarà grave. Ogni singolo atto quotidiano della persona con disabilità, si appoggerà costantemente sul supporto e sulla presenza di un’altra persona e finirà per costituire un vincolo tanto forte da pregiudicarle il normale svolgimento di tanti altri compiti (che inevitabilmente finiranno per essere considerati troppo marginali per essere anche solamente presi in considerazione). E le continue riduzioni di tutta una serie di possibilità, rese più difficili, sporadiche, acrobatiche, sembrerà dover concentrare tutta la propria esistenza attorno alla vita e all'esistenza di un unico soggetto. Non soltanto per l’aspetto materiale relativo ai bisogni della vita quotidiana ma anche per il necessario e costante impegno mentale. Pur svolgendo i genitori – o altre persone vincolate e implicate da rapporti di parentela o di amicizia – una personale professione, tutta la loro vita mentale sarà occupata costantemente dalla presenza di quel figlio, di quella figlia – o di quell’individuo – con disabilità.
Di qui, l’importanza di capire quanto al tempo vada restituita policromia; di capire quale sia il reale successo di quei compiti che occupano anche materialmente il tempo delle persone che vivono accanto a una persona con disabilità; soprattutto di capire che tipo di tempo vive l’individuo con esigenze particolari. Questo passaggio dalla monocromia alla policromia, il più delle volte avviene giorno dopo giorno. Può accadere che un essere umano con un deficit viva a lungo nella protezione che abbiamo chiamato monocromia. In questa condizione arriva all’università. Potrebbe pretendere trattamenti protettivi che esentino, ad esempio, dagli obblighi del cadenziario del calendario universitario. Come dovrà comportarsi chi assume un impegno tutoriale nei confronti di questo studente con disabilità? Le necessità organizzative dell’università sono indiscutibili. Misurare i bisogni e quantificare le risposte è necessario. È chiaro che non si può non fare i conti. La logica organizzativa può rispondere in maniera equa alle esigenze delle risorse economiche (con limiti) e alle esigenze dei soggetti? Si possono tenere in equilibrio le necessità che portano a oggettivare i bisogni e le necessità che portano a identificarsi con chi vive i bisogni? Potremmo cercare di semplificare il problema utilizzando strumenti di rilevazione dei bisogni e affidandone l’impiego a chi vive la quotidianità accanto ai soggetti con bisogni speciali. È un modo di arrivare a una soluzione equilibrata.
Chi assume un compito tutoriale corre alcuni rischi derivati dall’identificazione con l’altro. In particolare:
- può accadere che chi è Tutor ritenga che le necessità organizzative dei servizi (misurare i bisogni e quantificare le risposte) siano, come tutte le incombenze amministrative, attività che esulano dal proprio impegno. La conseguenza va nel rinforzo di quella divisione del lavoro che è all’origine dell’inadeguatezza del sistema.
- l’identificazione con l’altro come compito esclusivo di un Tutor logora (burn out).
- l’identificazione con l’altro può isolare e impedire di “leggere” i bisogni includendoli in una “lettura” sociale che permetta di mettere davvero in crisi la “categorizzazione” cui storicamente ci si riferisce. Le risposte individualizzate a bisogni individuali possono non essere per “categorie” e non essere individuali (isolate), ma intrecciare diversi individui in un’ eterogeneità compatibile. Il bisogno di avere un'abitazione - ad esempio - non riguarda una categoria (“ritardo intellettivo”), ma individui non “categorizzabili”. Se la risposta è tale da esigere una certa prossimità, la stessa risposta deve tener conto della compatibilità, accostando una proposta che sia nello stesso tempo vicina e progressiva (eterogeneità compatibile). Bisogna essere acrobati. Lorenzo Milani voleva che i figlioli affidati alla sua responsabilità di educatore, sapessero almeno mille parole, e non cento. Dovevano apprendere parole anche difficili. Per questo voleva essere vicino a ognuno di loro: per non proteggerli, ma volerli capaci. Era un acrobata: percorreva il filo che collega il non più con il non ancora. Ora tocca a noi.
Bibliografia
S. Friedlaner (1967; 1967), Kurt Gerstein e l’ambiguità del bene, Milano, Feltrinelli
H. Gardner (2005), Educazione e sviluppo della mente, Trento, Erickson.
A. Appadurai (a cura di) (2021), La vita sociale delle cose, Milano, Molteni.