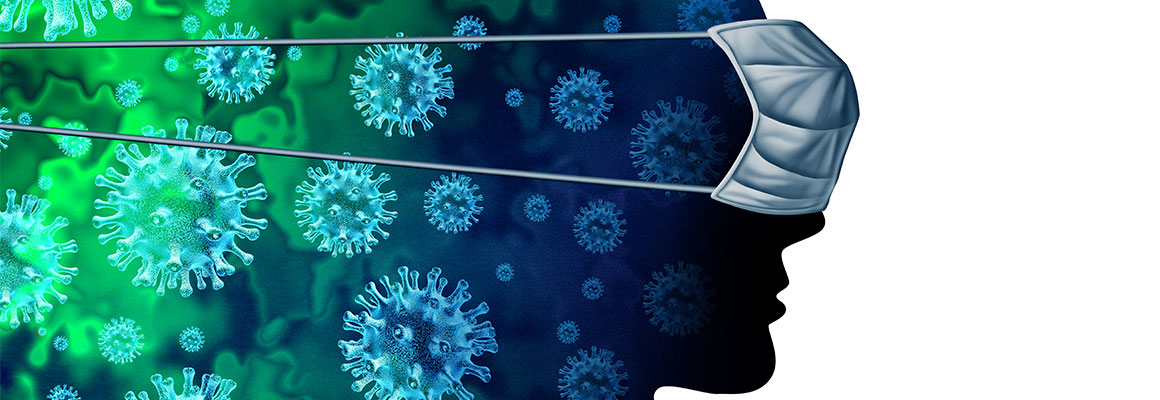Il fatto è - scriveva qualche giorno fa Jen Gunter sul New York Times - che questo coronavirus è talmente una cosa nuova, che semplicemente non sappiamo neanche cosa non sappiamo. Ecco, finalmente, un commento saggio su un argomento sul quale si è spesa sui media ogni parola possibile, dagli allarmismi più insensati, ai consigli new age per il gusto della riscoperta del tempo, e dei poteri taumaturgici della pasta fatta in casa.
Dovremmo, infatti, ammettere che una cosa è chiara più di tutte: nessuno sa esattamente cosa comporti, dal punto di vista dell’impatto psicologico sui bambini e sulle famiglie, questo strano e catastrofico esperimento sociale.
Certo, a prima vista tutti concordano sul fatto che a partirne di più, come sempre, sono e saranno i più deboli e i più poveri. Poveri in mezzi, risorse personali e psicologiche. Basti banalmente pensare che la meravigliosa esperienza della scuola online chiede alle famiglie non solo una connessione alla rete, ma anche tanti dispositivi quanti sono i figli. Diritto allo studio sì, ma proporzionale al numero di tablet e pc. Non solo. Che ne è poi dei bambini con disabilità intellettive, disturbi dell’apprendimento, dell’attenzione, per citare solo i tipi (forse) più banali e lineari di difficoltà evolutive?
Chiunque prima della crisi affidasse la gestione di delicati equilibri familiari all'ausilio di personale specializzato, a supporti educativi e psicologici esterni si trova oggi improvvisamente sguarnito e solo. E la solitudine sarà tanto più insidiosa quanto minori saranno i mezzi e le risorse della famiglia, e le fragilità di partenza del bambino e del suo mondo affettivo.
Quando tuttavia si guardano le cose da vicino, si scoprono anche alcuni fenomeni che danno nuova luce alle cosiddette conseguenze psicologiche della pandemia. Per esempio, da circa quindici anni gli Hikikomori – i ragazzetti giapponesi che si votano alla clausura telematica nella loro cameretta - erano divenuti the “new thing” degli psicopatologi, e il ritiro sociale dell’adolescente era diventato la nuova grande sfida delle scienze medico psichiatriche. È bastato il batter d’ali del nuovo flagello per cambiare in un istante lo spettro dei valori attraverso cui giudichiamo la desiderabilità dei comportamenti delle persone, per mettere a nudo - una volta di più – che le cose che chiamiamo con tanta enfasi “malattie mentali”, non sono quasi mai oggetti fisici del mondo (come lo è la frattura della tibia o la polmonite interstiziale), non sono invarianti universali sempre uguali in ogni tempo e luogo, ma sono per lo più costrutti socioculturali, largamente determinati dai valori dominanti del contesto. In men che non si dica l’osteggiato ritiro sociale, meritevole di ogni più incisivo e forzoso intervento trattamentale, educativo e psicofarmacologico, è divenuta la qualità personologica più adattiva della nuova socialità distanziata.
E che dire dell’agguerrita schiera degli esperti del trauma psichico? Pronti a difendere l’idea che anche il più minuscolo degli eventi avversi - se soggettivamente percepito come minaccioso e “traumatico” - assurge a patologia ed è dunque meritevole di ogni opportuno trattamento specializzato, oggi si confrontano con un dilemma tanto banale quanto definitivo. Che ne è di questa nozione individualista e consumista del trauma, buona anzi buonissima per il marketing di prodotti sanitari e rimedi a buon mercato, quando il fatto traumatico colpisce tutti, grandi e piccoli, in egual misura, su scala planetaria? È ancora un fatto traumatico? Siamo dunque tutti traumatizzati? Oppure dovremmo semplicemente accettare l’idea che questo fatto – intrinsecamente catastrofico - suggerisce che gli eventi avversi possono assumere una valenza “protettiva” proprio nella misura in cui abbandoniamo ogni prospettiva individualistica della sofferenza e recuperiamo una qualche idea solida e condivisa di collettività?
Questi esempi ci invitano a riflettere su almeno tre possibili insegnamenti.
Il primo è che se le categorie con cui distinguiamo i soggetti normali da quelli che hanno problemi psichici funzionano male in situazioni nelle quali mutano radicalmente le regole di convivenza sociale, questo ci deve ricordare che la malattia mentale non è un concetto assoluto, ma in larga parte relativo. Per quanto la psichiatria si orienti sempre più nella direzione di medicalizzare il suo sapere, questo tentativo è fallito ormai su molti fronti e l’attuale passaggio storico lo ricorda una volta di più.
Il secondo insegnamento, strettamente connesso al primo, è che il concetto medicale della sofferenza psichica contiene un’altra aberrazione particolarmente problematica, specie per i bambini e gli adolescenti, e cioè che rappresenta la sofferenza psichica come un problema puramente individuale, come un accidente che accade a una persona. Una malattia appunto, come la frattura della tibia e la polmonite interstiziale da covid.
La pandemia mostra invece, una volta di più, che il confine mutevole tra star bene e star male è frutto di continue negoziazioni collettive. Nasce al confine tra fattori protettivi, punti di forza, problemi e fattori di rischio, e nessuno di questi fattori è sempre universalmente tale in ogni luogo. Attiene dunque a valori di cui siamo poco consapevoli, che sono continuamente rimodulati e prendono senso solo all'interno di tipi contingenti e storicizzati di possibili relazioni sociali. Così, esattamente come in un qualsiasi episodio della serie Black Mirror, scopriamo che basta spingerci solo un passo oltre la soglia delle nostre routine e dei nostri modi di convivenza sociale, perché perda improvvisamente senso ciò che normalmente consideriamo strano, aberrante e anormale.
Il terzo insegnamento ci riconduce al punto di partenza. Alle cose che non sappiamo di non sapere. Il senso profondo di dubbio, disorientamento e incertezza in cui ci ha gettati questa vicenda invita tutti noi a riscoprire il valore della nostra profonda ignoranza, come un fattore positivo che sappia guidare i processi di conoscenza. Un invito a un’apertura rigorosa al dubbio e all'incertezza, uno stimolo a vivere l’ethos del nostro lavoro, sociale o clinico che sia, con un’attitudine mite e marginale.
Ogni atto di responsabilità sociale si fonda sulla possibilità di accogliere le domande dell’altro, ma ciò è impossibile quando la nostra mente è già satura di risposte.