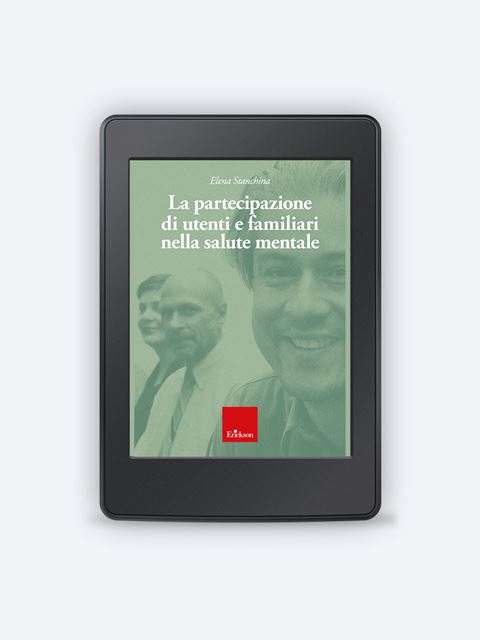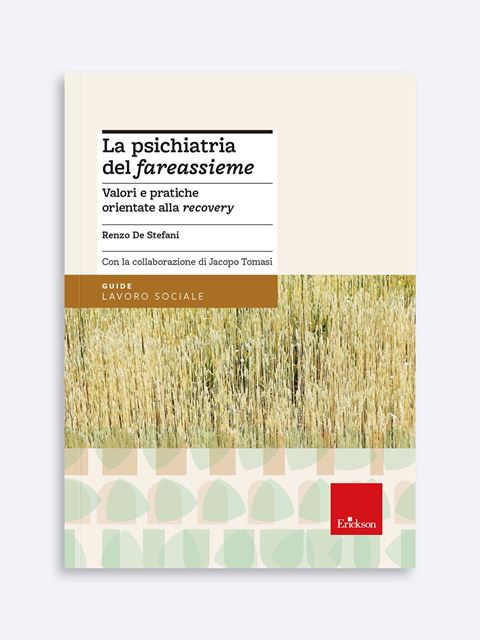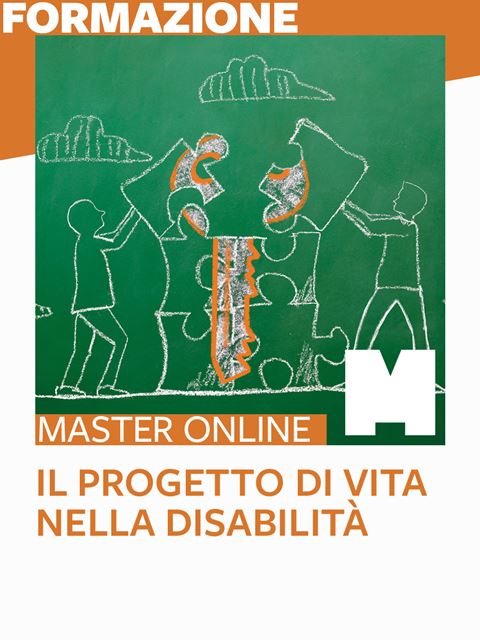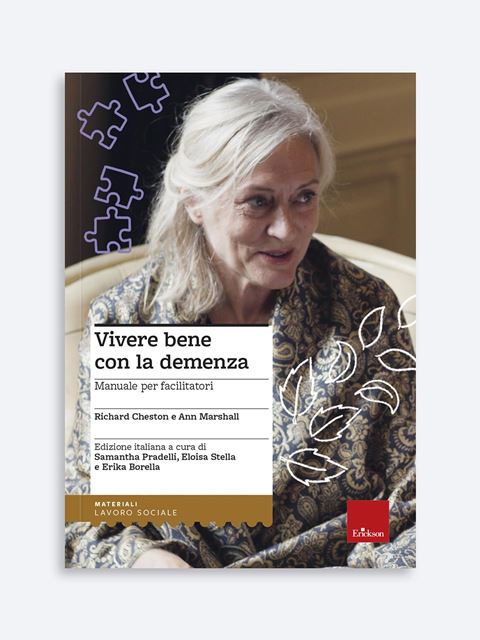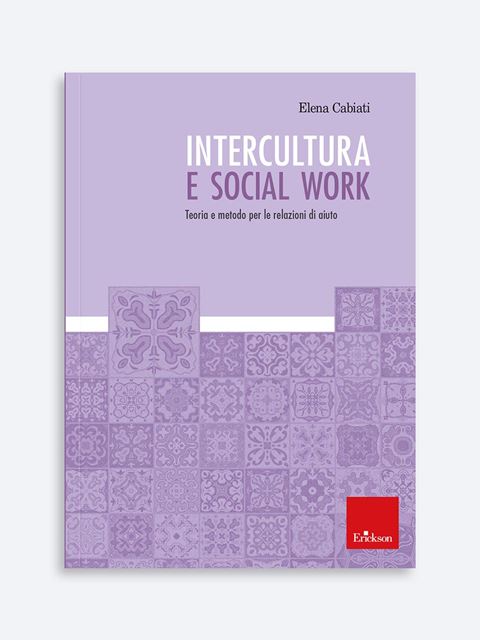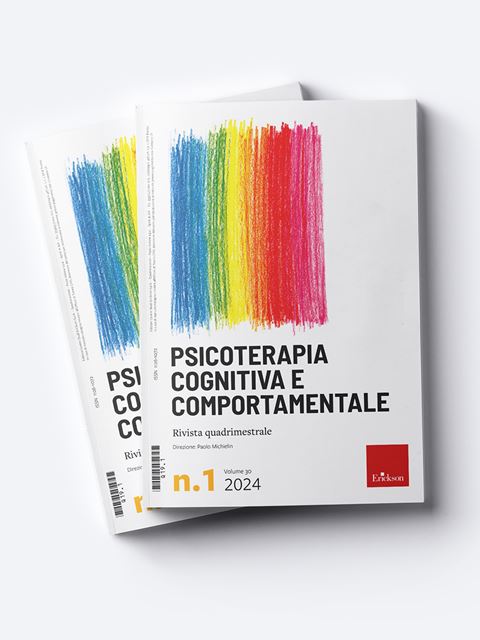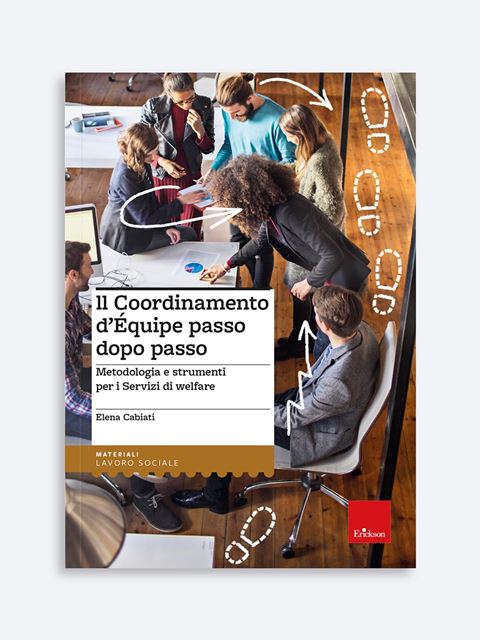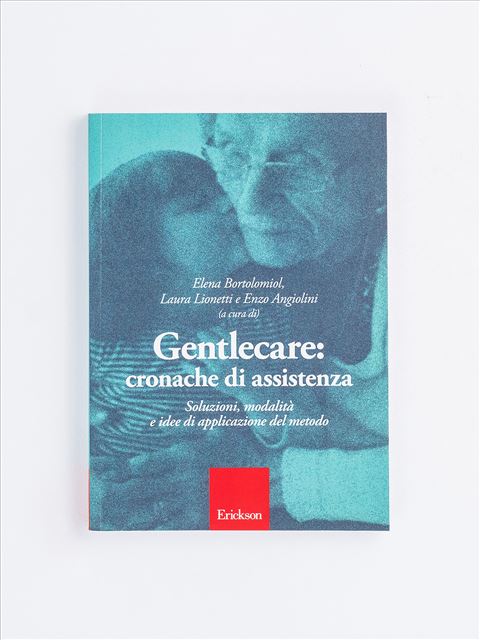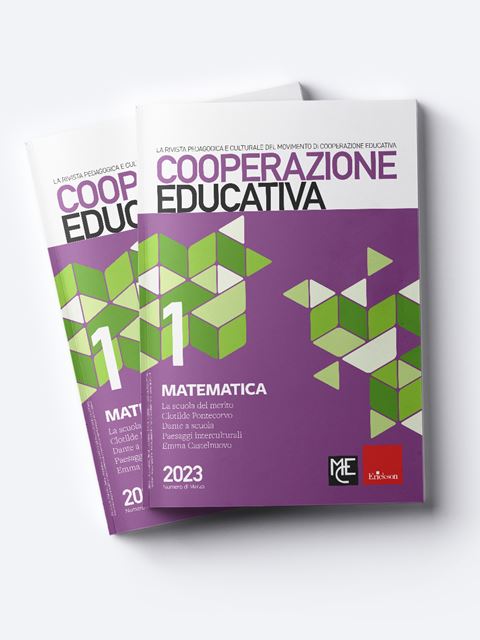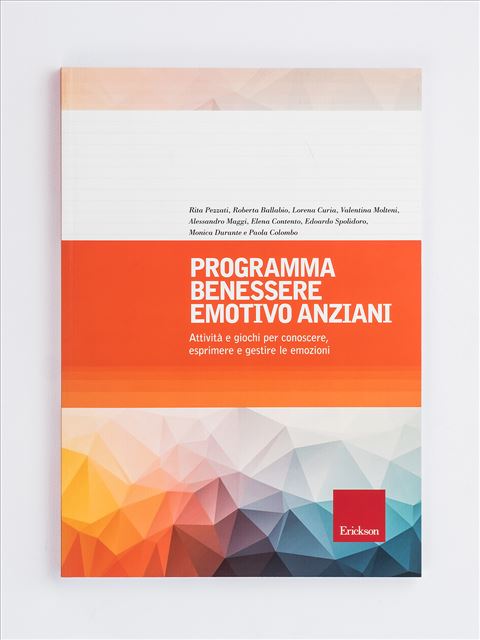Mondo Erickson
Il tuo carrello è vuoto
La partecipazione di utenti e familiari nella salute mentale
Il volume analizza il modo in cui i servizi di salute mentale possono accogliere al loro interno il punto di vista degli utenti e dei familiari, e propone strategie di azione e indicazioni operative per favorire pratiche partecipative efficaci nei servizi sociosanitari.
Il volume analizza il modo in cui i servizi di salute mentale possono accogliere al loro interno il punto di vista degli utenti e dei familiari, e propone strategie di azione e indicazioni operative per favorire pratiche partecipative efficaci nei servizi sociosanitari.
Il volume analizza il modo in cui i servizi di salute mentale possono accogliere al loro interno il punto di vista degli utenti e dei familiari, e propone strategie di azione e indicazioni operative per favorire pratiche partecipative efficaci nei servizi sociosanitari.
Descrizione
La partecipazione degli utenti e dei familiari nella progettazione, gestione e valutazione dei servizi di salute mentale è fondamentale per diverse ragioni, pratiche ed etiche.
Essa consente di migliorare l’efficacia dei servizi, di far valere le necessità e la prospettiva dei diretti interessati,...
La partecipazione degli utenti e dei familiari nella progettazione, gestione e valutazione dei servizi di salute mentale è fondamentale per diverse ragioni, pratiche ed etiche.
Essa consente di migliorare l’efficacia dei servizi, di far valere le necessità e la prospettiva dei diretti interessati, di aumentare il benessere organizzativo e individuale, di favorire l’empowerment e l’assunzione di responsabilità, di sviluppare il capitale sociale nella comunità territoriale e di mettere in discussione i pregiudizi legati alla malattia mentale. Nonostante questi effetti positivi, per i servizi può risultare faticoso aprirsi all’apporto di utenti e familiari, a causa di fattori culturali e storici. Spesso l’utente viene visto come debole e passivo, anziché come fonte di preziose e insostituibili conoscenze esperienziali.
A partire da tali considerazioni, la ricerca presentata in questo volume mira ad analizzare il modo in cui i servizi di salute mentale possono accogliere al loro interno il punto di vista degli utenti e dei familiari. Attraverso l’analisi del Fareassieme del Servizio di salute mentale di Trento e del Social Point del Dipartimento di salute mentale di Modena, si propongono strategie di azione e indicazioni operative per favorire pratiche partecipative efficaci nei servizi sociosanitari.
La partecipazione degli utenti e dei familiari nella progettazione, gestione e valutazione dei servizi di salute mentale è fondamentale per diverse ragioni, pratiche ed etiche.
Essa consente di migliorare l’efficacia dei servizi, di far valere le necessità e la prospettiva dei diretti interessati,...
La partecipazione degli utenti e dei familiari nella progettazione, gestione e valutazione dei servizi di salute mentale è fondamentale per diverse ragioni, pratiche ed etiche.
Essa consente di migliorare l’efficacia dei servizi, di far valere le necessità e la prospettiva dei diretti interessati, di aumentare il benessere organizzativo e individuale, di favorire l’empowerment e l’assunzione di responsabilità, di sviluppare il capitale sociale nella comunità territoriale e di mettere in discussione i pregiudizi legati alla malattia mentale. Nonostante questi effetti positivi, per i servizi può risultare faticoso aprirsi all’apporto di utenti e familiari, a causa di fattori culturali e storici. Spesso l’utente viene visto come debole e passivo, anziché come fonte di preziose e insostituibili conoscenze esperienziali.
A partire da tali considerazioni, la ricerca presentata in questo volume mira ad analizzare il modo in cui i servizi di salute mentale possono accogliere al loro interno il punto di vista degli utenti e dei familiari. Attraverso l’analisi del Fareassieme del Servizio di salute mentale di Trento e del Social Point del Dipartimento di salute mentale di Modena, si propongono strategie di azione e indicazioni operative per favorire pratiche partecipative efficaci nei servizi sociosanitari.
La partecipazione degli utenti e dei familiari nella progettazione, gestione e valutazione dei servizi di salute mentale è fondamentale per diverse ragioni, pratiche ed etiche.
Essa consente di migliorare l’efficacia dei servizi, di far valere le necessità e la prospettiva dei diretti interessati,...
La partecipazione degli utenti e dei familiari nella progettazione, gestione e valutazione dei servizi di salute mentale è fondamentale per diverse ragioni, pratiche ed etiche.
Essa consente di migliorare l’efficacia dei servizi, di far valere le necessità e la prospettiva dei diretti interessati, di aumentare il benessere organizzativo e individuale, di favorire l’empowerment e l’assunzione di responsabilità, di sviluppare il capitale sociale nella comunità territoriale e di mettere in discussione i pregiudizi legati alla malattia mentale. Nonostante questi effetti positivi, per i servizi può risultare faticoso aprirsi all’apporto di utenti e familiari, a causa di fattori culturali e storici. Spesso l’utente viene visto come debole e passivo, anziché come fonte di preziose e insostituibili conoscenze esperienziali.
A partire da tali considerazioni, la ricerca presentata in questo volume mira ad analizzare il modo in cui i servizi di salute mentale possono accogliere al loro interno il punto di vista degli utenti e dei familiari. Attraverso l’analisi del Fareassieme del Servizio di salute mentale di Trento e del Social Point del Dipartimento di salute mentale di Modena, si propongono strategie di azione e indicazioni operative per favorire pratiche partecipative efficaci nei servizi sociosanitari.
ISBN: 9788859035459
Data di pubblicazione: 03/2023
Requisiti di sistema:
- Questo ebook è realizzato in formato pdf e protetto con social watermarking.
- Può essere letto su tutti i dispositivi in cui sia presente un applicativo in grado di leggere i file pdf.
- Non è stampabile.
- Per maggiori informazioni vedi la Guida alla lettura degli E-BOOK.
Indice:
Prefazione
Prima parte – La cassetta degli attrezzi
C’è partecipazione e partecipazione. Luoghi, attori e ostacoli del coinvolgimento di utenti e familiari
• Il gioco del «servizio totale»: una metafora che fa da monito
• Gli utenti e i familiari come co-protagonisti
• La partecipazione nei diversi modelli di welfare
• L’oggetto e la finalità della partecipazione
• I livelli della partecipazione
• La questione del potere e l’empowerment
• La cultura organizzativa e l’apertura alla partecipazione degli utenti
• La qualità relazionale dei servizi di salute mentale
• L’orientamento al recovery
• Le sei trappole per la partecipazione
Nasce una ricerca. Metodi, strumenti e riflessioni
• Il paradigma della ricerca
• La scelta dei casi
• Gli strument
• L’analisi dei dat
• La discussione dei risultat
• Una riflessione su alcune questioni etiche
Due storie diverse di partecipazione. Il Fareassieme di Trento e il Social Point di Modena
• Il Fareassieme nel Servizio di salute mentale di Trento
• Il Social Point nel Dipartimento di salute mentale di Modena
Seconda parte – Alla ricerca di significati
Il Fareassieme si racconta. Tra rivoluzione, sensibilizzazione e pratiche consolidate
• Gli operatori nel Fareassieme
• Le criticità nell’area Fareassieme
• Le attività strutturate che meglio rappresentano il Fareassieme
• Il Fareassieme come approccio
• La formalizzazione del Fareassieme
Il Social Point si racconta. Tra rottura, territorio e obiettivi molteplici
• Gli operatori del Social Point
• Un’isola metodologica
• Una sovrapposizione di obiettivi diversi
• Il rapporto tra il Social Point e gli altri servizi
• Il riconoscimento formale da parte del Dipartimento di salute mentale
• Il cambiamento di atteggiamento
• Le questioni aperte del Social Point
• Gli elementi chiave nella storia del Social Point
• Il rapporto con i familiari
Terza parte – La partecipazione organizzata
L’emergere di nuovi approcci. Il versante del cambiamento
• I principi del Fareassieme come comune denominatore
• I promotori e i luoghi del cambiamento culturale
• Le strategie per il cambiamento
• Le sottoculture organizzative: il caso degli psichiatri
• Le vittime del cambiamento
Il consolidarsi della partecipazione. Il versante della strutturazione
• I gruppi di auto/mutuo aiuto
• Le riunioni con i familiari per presentare il Servizio
• I tavoli misti volti a migliorare/progettare il Servizio
• La progettazione condivisa del percorso di cura
• La sensibilizzazione della cittadinanza
• Gli Utenti e Familiari Esperti (UFE)
• L’incardinamento delle pratiche partecipative
• La relazionalità dei servizi
Dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda. Due esperienze oltreconfine
• I Peer Support Technicians del Department of Veterans Affairs (USA)
• I Peer Support Workers della Mind & Body (Nuova Zelanda)
• Alcune considerazioni metodologiche
Conclusioni. Decalogo per i manager e spunti per la ricerca
Bibliografia
ISBN: 9788859035459
Data di pubblicazione: 03/2023
Requisiti di sistema:
- Questo ebook è realizzato in formato pdf e protetto con social watermarking.
- Può essere letto su tutti i dispositivi in cui sia presente un applicativo in grado di leggere i file pdf.
- Non è stampabile.
- Per maggiori informazioni vedi la Guida alla lettura degli E-BOOK.
Indice:
Prefazione
Prima parte – La cassetta degli attrezzi
C’è partecipazione e partecipazione. Luoghi, attori e ostacoli del coinvolgimento di utenti e familiari
• Il gioco del «servizio totale»: una metafora che fa da monito
• Gli utenti e i familiari come co-protagonisti
• La partecipazione nei diversi modelli di welfare
• L’oggetto e la finalità della partecipazione
• I livelli della partecipazione
• La questione del potere e l’empowerment
• La cultura organizzativa e l’apertura alla partecipazione degli utenti
• La qualità relazionale dei servizi di salute mentale
• L’orientamento al recovery
• Le sei trappole per la partecipazione
Nasce una ricerca. Metodi, strumenti e riflessioni
• Il paradigma della ricerca
• La scelta dei casi
• Gli strument
• L’analisi dei dat
• La discussione dei risultat
• Una riflessione su alcune questioni etiche
Due storie diverse di partecipazione. Il Fareassieme di Trento e il Social Point di Modena
• Il Fareassieme nel Servizio di salute mentale di Trento
• Il Social Point nel Dipartimento di salute mentale di Modena
Seconda parte – Alla ricerca di significati
Il Fareassieme si racconta. Tra rivoluzione, sensibilizzazione e pratiche consolidate
• Gli operatori nel Fareassieme
• Le criticità nell’area Fareassieme
• Le attività strutturate che meglio rappresentano il Fareassieme
• Il Fareassieme come approccio
• La formalizzazione del Fareassieme
Il Social Point si racconta. Tra rottura, territorio e obiettivi molteplici
• Gli operatori del Social Point
• Un’isola metodologica
• Una sovrapposizione di obiettivi diversi
• Il rapporto tra il Social Point e gli altri servizi
• Il riconoscimento formale da parte del Dipartimento di salute mentale
• Il cambiamento di atteggiamento
• Le questioni aperte del Social Point
• Gli elementi chiave nella storia del Social Point
• Il rapporto con i familiari
Terza parte – La partecipazione organizzata
L’emergere di nuovi approcci. Il versante del cambiamento
• I principi del Fareassieme come comune denominatore
• I promotori e i luoghi del cambiamento culturale
• Le strategie per il cambiamento
• Le sottoculture organizzative: il caso degli psichiatri
• Le vittime del cambiamento
Il consolidarsi della partecipazione. Il versante della strutturazione
• I gruppi di auto/mutuo aiuto
• Le riunioni con i familiari per presentare il Servizio
• I tavoli misti volti a migliorare/progettare il Servizio
• La progettazione condivisa del percorso di cura
• La sensibilizzazione della cittadinanza
• Gli Utenti e Familiari Esperti (UFE)
• L’incardinamento delle pratiche partecipative
• La relazionalità dei servizi
Dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda. Due esperienze oltreconfine
• I Peer Support Technicians del Department of Veterans Affairs (USA)
• I Peer Support Workers della Mind & Body (Nuova Zelanda)
• Alcune considerazioni metodologiche
Conclusioni. Decalogo per i manager e spunti per la ricerca
Bibliografia